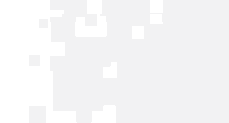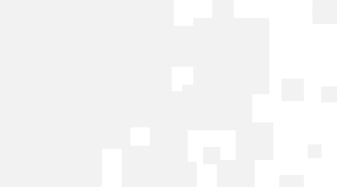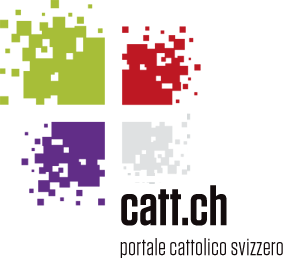«Io prete arabo per la Chiesa che parla ebraico»
La loro casa a Gerusalemme si trova nella via dedicata ad HaRav Kook, il rabbino capo ai tempi del Mandato britannico; Mea Shearim, il celebre quartiere degli haredim, è a poche centinaia di metri. Nella cappella il candelabro è a sette braccia, la messa si celebra in ebraico e l’Eucaristia è una matzah spezzata dal celebrante, come deve aver fatto Gesù nell’Ultima Cena. Insieme alle comunità di Haifa, Tel Aviv e Beer Sheva, Casa San Simeone e Anna a Gerusalemme è il cuore del Vicariato di San Giacomo per i cattolici di espressione ebraica in Israele. È la piccola comunità rinata negli anni Cinquanta, all’interno del Patriarcato latino di Gerusalemme, come eredità vivente della comunità giudeo-cristiana nata dalla prima predicazione di Gesù e degli apostoli. Formata da persone giunte al cristianesimo con storie diverse ma tutte fortemente legate a un contesto ebraico, è un ponte naturale tra la Chiesa cattolica e l’Israele di oggi. E da qualche settimana ha una nuova guida che in qualche modo ne segna un nuovo passaggio: il gesuita israeliano padre David Neuhaus ha infatti passato il testimone a padre Rafica Nahra, 58 anni, sacerdote di origini libanesi. Un arabo, dunque, come vicario della comunità che è segno vivente del legame inscindibile tra la Chiesa e il popolo ebraico.
Padre Rafic come mai un prete libanese per questo compito?
«Da qualche anno ero già il responsabile della comunità locale di Gerusalemme. La mia storia qui comincia quando nel 1979 lasciai il Libano con una borsa di studio per la facoltà di ingegneria a Parigi: pensavo di tornare, ma a causa della guerra prolungai il mio soggiorno in Francia, cominciai a lavorare lì. E a quel punto arrivò la chiamata al sacerdozio: sono diventato prete dell’arcidiocesi di Parigi negli anni in cui era arcivescovo il cardinale Jean-Marie Lustiger».
E da Parigi come arrivò a Gerusalemme?
«La prima volta venni nel 1993: studiavo a Roma al Pontificio Istituto Biblico e il mio piano di studi prevedeva un semestre a Gerusalemme. Era la prima volta che entravo in contatto con il mondo ebraico in Israele; vedevo questa società e da arabo mi rendevo conto di quanto profonda fosse l’incomprensione e l’ignoranza reciproca. Fu un’esperienza decisiva per me. Prima di venire a Gerusalemme ero più sensibile al tema dell’ecumenismo, nella mia famiglia stessa ci sono cattolici, ortodossi, protestanti. Ma ora questa separazione tra ebrei e arabi mi colpiva. Non tanto la dimensione religiosa: la ferita tra ebrei e cristiani è più sensibile in Europa, dove gli ebrei hanno sofferto molto. A Gerusalemme vedevo piuttosto la paura, l’odio, l’incomprensione tra i due popoli. Così in me è nato il desiderio di ritornare qui come prete: non per proporre soluzioni politiche, non è il mio ambito; a me premeva fare qualcosa che aiutasse a vivere meglio insieme. Far capire che dietro alla diffidenza non c’è solo la politica, ma anche quella sfera umanissima che è la paura dell’altro. A Parigi così ho iniziato a occuparmi delle relazioni tra cristiani ed ebrei; poi, nel 2004, ho chiesto di tornare a Gerusalemme per studiare il pensiero ebraico. Ho conseguito un dottorato in letteratura giudeo-araba alla Hebrew University e come prete ho cominciato a lavorare nel Vicariato di San Giacomo».
Quanto il cardinale Lustiger – figlio di famiglia ebraica, con la sua storia personale di figura-ponte tra ebrei e cristiani – è stato ed è ancora un punto di riferimento per voi?
«Per me è stato un uomo di Dio, una figura profetica. Era un uomo che viveva profondamente quanto diceva. È chiaro: lui ha incoraggiato il mio interesse per il rapporto tra la Chiesa e il mondo ebraico; ma questa mia vocazione è maturata poco alla volta. Penso però che la sua eredità resti soprattutto in Francia. È vero, anche tra i fondatori delle comunità del nostro Vicariato c’erano molti francesi: coppie miste ebraico-cristiane, persone venute dopo la Shoah a Gerusalemme con l’intenzione di riparare il rapporto tra cristiani ed ebrei. Per loro Lustiger è stato un punto di riferimento fondamentale. Poi però le cose anche qui sono andate avanti: certo, ci chiediamo ancora quale tipo di rapporto esista tra noi e il popolo ebraico. Ma più che come riflessione teologica qui a Gerusalemme la viviamo come esperienza di vita condivisa. Per esempio ogni mese ci ritroviamo con alcuni amici di una sinagoga a studiare insieme i testi dell’Antico Testamento e anche qualche pagina del Nuovo Testamento. È un gruppo che guarda con preoccupazione a certe forme di chiusura che attraversano oggi la società israeliana. Ed è un modo per conoscersi a vicenda e vivere davvero insieme».
I pregiudizi sono ancora così forti come quando arrivò nel 1993?
«I pregiudizi restano: ne incontro ancora tanti, dappertutto. Però è impossibile lavorare in generale sui pregiudizi; li si combatte solo attraverso l’incontro concreto tra le persone. Ed è quanto come comunità proviamo a fare a Gerusalemme con i nostri contatti con le comunità del mondo ebraico ma anche con tanti musulmani aperti al dialogo. È il metodo dell’irradiazione, piuttosto che dei congressi internazionali. Perché alla fine dei convegni si scrivono articoli e documenti molto belli, ma incidono troppo poco sulla realtà…».
Oggi la vostra comunità è fortemente impegnata accanto ai migranti e richiedenti asilo cristiani (filippini, indiani, eritrei, sudanesi) giunti in Israele per lavorare o fuggire a situazioni di guerre e persecuzioni. Nei piccoli centri di Tel Aviv e a Casa Rachele a Gerusalemme, in particolare, vi prendete cura dei loro figli, che crescono in un contesto che non offre loro alcuna forma di tutela giuridica…
«Non è un impegno solo nostro: è una sfida per tutto il Patriarcato latino. Ma questi ragazzi parlano ebraico, crescono nella società israeliana e dunque è naturale che interpellino prima di tutto noi. Si sentono israeliani a tutti gli effetti: vanno a scuola, conoscono solo Israele, non hanno mai visto il Paese d’origine, sostengono l’esercito israeliano (del resto fare il servizio militare per loro oggi è l’unica possibilità per ottenere la cittadinanza). Quando i politici parlano di rimandarli nei Paesi d’origine è una catastrofe: hanno le loro radici qui, amano Israele, non capiscono. Oltre all’assistenza cerchiamo di dare loro un’identità cristiana, senza però creare ghetti che ostacolino il loro bisogno di integrarsi nella società israeliana. Non è facile: queste sono cose da adulti. Per esempio, la lettura della Bibbia che viene proposta a scuola ovviamente è quella ebraica. Così proviamo a leggere con loro gli stessi testi con uno sguardo cristiano. Del resto anche con i genitori quando parli del compimento delle profezie il legame non sempre è immediato. Non che sia impossibile, ma è un cammino che richiede impegno. Poi ovviamente c’è tutta la parte sociale di questo lavoro: sono poveri, in condizioni precarie, pagati pochissimo per i loro lavori, molti bambini e ragazzi filippini sono qui solo con la madre… Viviamo dei doni che riceviamo per aiutarli; altrimenti chiuderemmo domattina. E ci sono anche ebrei israeliani che vengono ad aiutarci: sanno che siamo cristiani, ma non vengono per la religione; vengono per aiutare i bambini a fare i compiti».
Questo impegno sta cambiando la vostra comunità?
«È una sfida giunta un po’ inaspettata. Nel Vicariato siamo in tutto un migliaio di persone e i bisogni di questi fratelli sono enormi, servirebbe molto di più. A volte anche tra noi c’è un po’ di inquietudine. C’è chi dice: abbiamo la nostra identità di Chiesa locale, se lavoriamo con tante persone che vengono da altri Paesi non rischiamo di perderla? La risposta a questa domanda non può essere teorica. Quando ci ritroviamo con questi bambini che vivono qui, parlano la nostra lingua, si sentono parte della società in cui viviamo, come potremmo dire loro: no, noi non possiamo aiutarvi perché abbiamo questa o quella identità? Se il povero ti sta accanto devi aiutarlo. Per l’identità ci sarà tempo… Del resto diciamo che loro sono i migranti, ma alla fine chi siamo noi? Io che vengo dalla Francia ho più diritto a stare qui di una donna che viene dalle Filippine? E chi è Israele stesso? Anche gli ebrei che sono venuti nel 1948 erano tutti migranti; certo, per loro è stato un ritorno nella Terra di Israele, ma è stata comunque un’immigrazione. Siamo sicuri che per i filippini, gli eritrei o i sudanesi sia diverso? E che la profezia su Gerusalemme come casa di preghiera per tutti i popoli oggi non ci dica qualcosa anche su questo?».
Giorgio Bernardelli – VaticanInsider