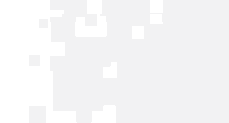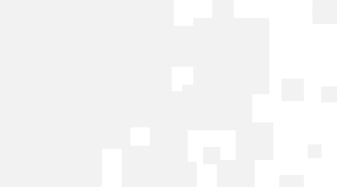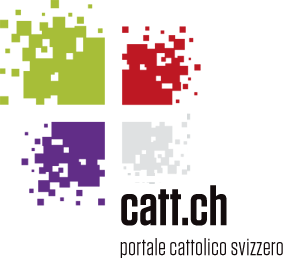Il gesuita inventore che libera le donne dalla «schiavitù» del fuoco
Dall’Italia all’Africa, e viceversa. Da quasi trent’anni. Da quando, dopo essere entrato come «coadiutore temporale» nella Compagnia di Gesù a 28 anni (tra i religiosi non sacerdoti, solitamente chiamati Fratelli Gesuiti), a 42 rispose concretamente a una richiesta di aiuto giunta dal Ciad. «Mi rigirai la lettera fra le mani per qualche giorno poi decisi di partire. Non conoscevo niente dell’Africa, della realtà politica, delle cause dei conflitti Nord-Sud, che poi ho scoperto essere alibi politici. Ma ciò non doveva impedirmi di fare qualcosa per i più poveri. Così raggiunsi il mio confratello, atterrai a Bangui, 700 km a sud di Sarh, lungo una strada dove l’unica industria vista era uno zuccherificio. Era il 1980. E in Ciad decisi di fermarmi convinto che non si può parlare di Dio se prima non si offre che di sfamarsi». Da allora, ogni anno, circa sette mesi tra le comunità dei Gesuiti di Bergamo (ora chiusa) e Selva di Valgardena (nella casa di esercizi detta «Villa Capriolo»), o in giro per l’Italia a cercare materiali e mantenere contatti con i (pochi) benefattori; poi gli altri cinque mesi in Ciad, a Sarh (nel Sud), talora a Mongo (nel Nord), in luoghi ancor piuttosto primitivi: capanne e deserto, miseria e malattie, clima insopportabile non meno dell’imperante cultura tribale, verticistica e maschilista. E proprio lì – alternando periodi relativamente tranquilli, ad altri dove è finito persino sotto le grinfie dei ribelli armati antigovernativi – ha portato quello che lui chiama «il Vangelo delle mani».
È così che fratel Pietro Rusconi, definisce il senso della sua presenza in una zona dove la Chiesa cattolica locale è relativamente giovane, in un Paese a maggioranza islamica e nel quale l’animismo resta la religione dei Padri, quella più antica, anche se un po’in declino. «Io però non sono un predicatore. Non mi sono mai messo a parlare di Dio con gli operatori che ho formato quasi tutti di fede islamica. In ogni caso quando si sono presentate occasioni di confronto o dialogo religioso non mi sono sottratto. Mi interessa un rapporto alla pari, di amicizia, di solidarietà. Mi interessa evangelizzare con l’esempio, aiutando i poveri con rispetto e concretezza», ci dice questo religioso bravo meccanico con doti di inventore.
Sì perché fratel Pietro all’inizio ha inventato rudimentali attrezzi per i contadini, poi le «carrozzelle per il deserto», tricicli con pedali e catene sul manubrio utilizzate da persone colpite da atrofie muscolari spinali, purtroppo qui in gran numero; inoltre ha realizzato particolari lettini per centri medici e dispensari e, ancora, presse per produrre mattoni e pompe a mano per estrarre acqua dai pozzi; infine – da diversi anni – ha portato laggiù le «cucine solari» (in pratica pannelli a forma di parabola con dimensioni e angolature adatte a sfruttare al meglio il calore) ed ora insegna a costruire in loco nuovi focolari in lamiera (i cosiddetti «foyers améliorés»). Tutte microrealizzazioni di cui fratel Rusconi va fiero. Le ultime in particolare perché sono il suo modo, afferma, di «liberare le donne da tante fatiche e dalla «schiavitù» del fuoco, valorizzando un’energia, pulita e rinnovabile a costo zero, come quella solare, rispettando l’ambiente, risparmiando gli alberi, riducendo la desertificazione e il disboscamento».
Così si usa il sole, invece che il fuoco e la legna, per cucinare, bollire l’acqua, ottenere energia: «Certo, un grande dono per queste donne africane che da sempre passano ore sotto il sole cocente a recuperare legna e sterpi a chilometri e chilometri dalle loro capanne, o stanno inginocchiate a custodire il fuoco alimentandolo con quanto hanno trovato in ambienti dove la vegetazione è già scarsa per preparare il consueto piatto quotidiano, la boule, una polenta di miglio poco saporito», racconta fratel Pietro. E aggiunge: «Questa parabola solare rende le donne delle vere signore, non più schiave. Non stanno più a spaccarsi la schiena nella Savana per raccogliere legna e arbusti, a trascinare fascine per ore, non devono più neanche dipendere dai mariti per comprare costoso carbone o petrolio. E hanno tempo per curare dei piccoli orti e portare al mercato qualcosa da vendere. Con il sole una pentola di 20 litri bolle in tre quarti d’ora, la donna si limita a spostare la parabola, non respira fumo, non ci sono rischi di ustioni per i bambini più piccoli… E non è tutto perché usata in un certo modo la «cucina» permette anche il funzionamento dei frigoriferi e dei contenitori per conservare stock di medicinali, qualcosa di veramente utile negli ospedali, nelle missioni».
A dirla tutta sono stati i tedeschi ad averla progettata e fatta conoscere in Africa e in America Latina, si tratta di kit relativamente poco costosi, ma realizzati ovviamente per guadagnarci. «Io ho voluto che potessero averla anche i poveri. Come? Abbiamo abbattuto costi assemblando i vari pezzi qui, insegnando a costruire sul posto le intelaiature metalliche, e i prezzi sono scesi. I materiali li importiamo dall´Europa e magari fanno l’ultimo tratto di strada sulle gobbe di cammelli, ma parte della produzione si fa qui… Così una famiglia riesce ad ammortizzare in poco tempo l´acquisto della cucina solare, grazie al risparmio del combustibile. Senza scordare che con questo contributo in denaro paghiamo gli stipendi delle persone che lavorano con noi, spesso mariti e padri delle donne che beneficiano delle cucine. E pensare che all´inizio le gente del villaggio pensava che il macchinario fosse «diabolico»: poi pian piano tante donne – visti i benefici – ce le hanno chieste ».
«Certo, ad essere sinceri, ci siamo resi conto che le «cucine solari» vanno bene soprattutto per le donne che comunque possono stare a casa, hanno mariti che uno stipendio sicuro ce l’hanno; non per quelle che invece devono andare nei campi talvolta lontani, partendo il mattino e tornando la sera nelle loro capanne… Ci siamo interrogati su come intervenire, tenendo il loro passo, perché l’importante è il condividere, e in base alle loro esigenze, fabbrichiamo ora i cosiddetti i focolari «ameliorés», cucinette metalliche, aperte sul davanti, con l’intercapedine riempita su tre lati di materiale come la lamiera e la ghiaia, reperibile in loco. Il consumo di combustibile è notevolmente ridotto: bastano dei legnetti che gli stessi bambini possono raccogliere non lontano dalla capanne . Di fatto sono delle speci di stufe. Anche qui, viste le cifre d’acquisto che per loro sarebbero insostenibili, si è deciso di non regalarle, ma di chiedere un contributo ragionevole. Certo anche in questo caso è un bel passo: si sostituisce il vecchio focolare, cioè un buco nel terreno riempito di pezzi di legna su cui tre sassi sostengono la marmitta in cui cuoce, due volte al giorno, la boule, con uno spreco di calore immenso, che diventa tormento per la temperatura e il fumo, e, al loro posto, abbiamo queste cucinette economiche in lamiera che si scaldano rapidamente, mantenendo il calore all’interno, senza sprechi».
Dettagli tecnici a parte, si capisce ormai che si sta parlando di mezzi per ridare dignità alla condizione della donna, di salvaguardia dell’ambiente, di lotta alla povertà… Si tratta proprio degli impegni di un missionario? Così domandava a fratel Pietro l’ultimo numero di Gesuiti Missionari Italiani, la rivista del Magis, con un articolo sulla sua testimonianza in Ciad. La sua risposta, ricordate le novità citate, le nuove possibilità di lavoro, il ruolo delle Banche dei Cereali grazie alle quali la popolazione rurale è stata liberata da tanti strozzini, i miglioramenti recati dall’apertura di scuole non solo per i bambini ma anche per gli adulti, sottolineava però innanzitutto lo spirito di condivisione e solidarietà alla base di tutto questo, non disgiunto dall’appartenenza ad una terra che chiede di non essere abbandonata. «È in questa direzione che noi lavoriamo: tenere salda la coesione, migliorando le condizioni di vita, salute, dignità umana, tutela della loro terra… Allora il Vangelo che annunciamo è credibile, perché la Parola non risuona nell’orecchio, ma scende dentro di loro, è vissuta, incarnata nella quotidianità e germoglia. Sì, mi sento un missionario».
Un missionario che tra poche settimane volerà di nuovo in Ciad richiesto dai gesuiti dell’Ospedale del Buon Samaritano di N’Djaména, per formare giovani manutentori capaci di riparare gli arredi deteriorati della struttura. «Rimarrò con loro il tempo necessario per impiantare un’officina ed occuparmi dell’apprendistato, poi li lascerò lavorare da soli… Tornerò a verificare? A fare altro? Di lavoro da fare ce n’è! Sì, è il dono del lavoro che mi fa il Signore, con me ancora così generoso da permettermi di pensare, a 78 anni, ad altri progetti… Quelli del Vangelo delle mani».