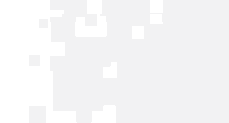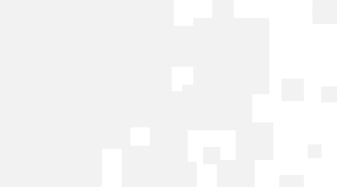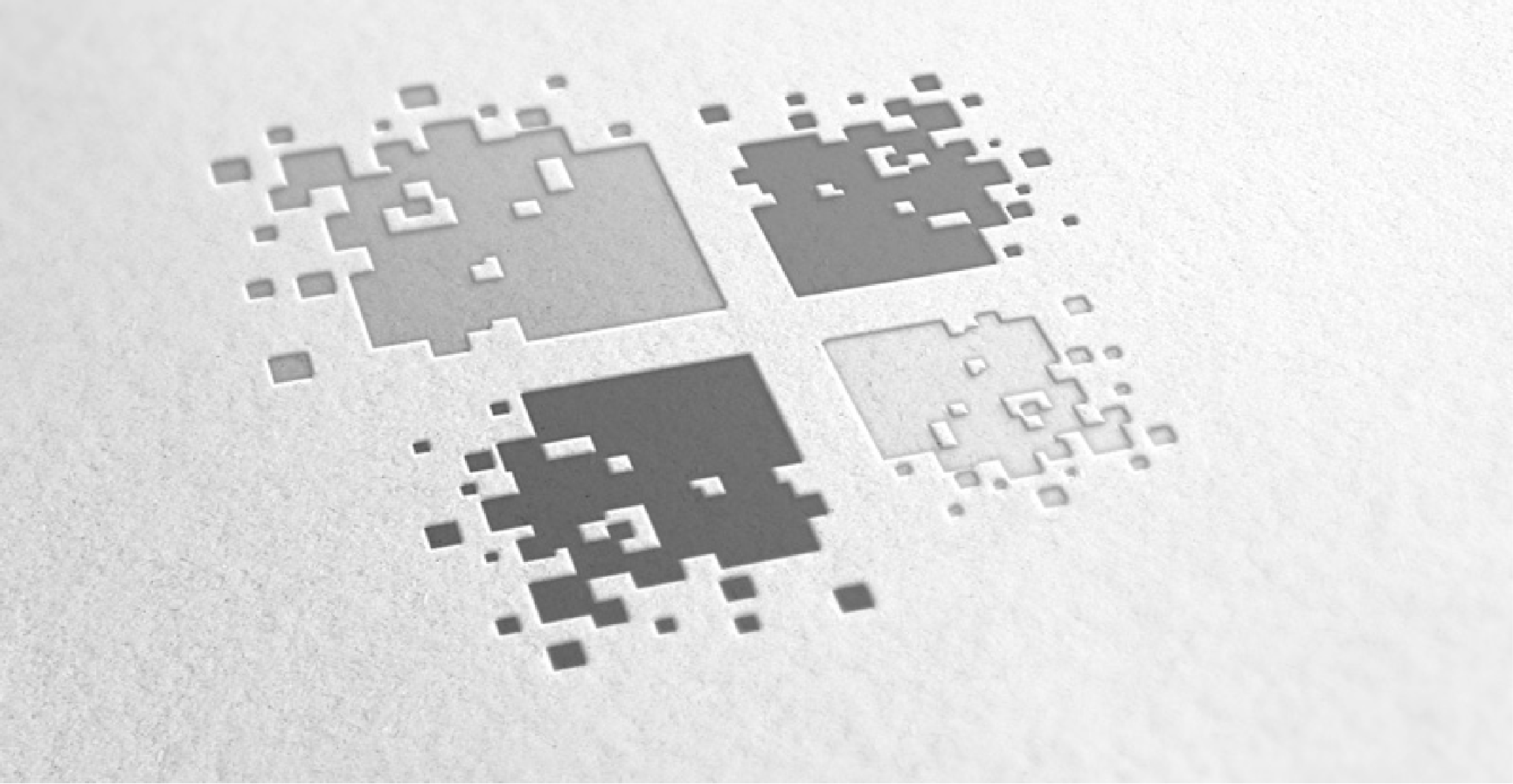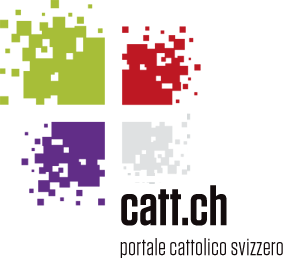La testimonianza di una famiglia di profughi siriani – Vittime di un traffico senza pietà
Jasmine è una bambina siriana di dieci anni, ha grandi occhi scuri e un sorriso appena accennato. Non ha voglia di parlare Jasmine, perché le parole più difficili che ha da dire sono annegate nel mare libico. Insieme a suo fratello. Quando il barcone su cui cercavano di attraversare il Mediterraneo è naufragato, a quindici miglia dalle coste di Sabratha. Jasmine ha grandi occhi scuri, tristissimi.
Oggi vive alla periferia di Misurata con sua madre, suo padre e il fratello che le resta, Bilal di quattro anni. Nel 2014 la famiglia di Jasmine è scappata da Damasco. «Ovunque andassimo la morte ci seguiva. Abbiamo vagato in Siria, in cerca di un posto sicuro — dice suo padre — ma un posto sicuro non c’era. Perciò ho deciso che era arrivato il momento di provare ad arrivare in Europa».
Ibrahim a Damasco era un muratore «povero, ma ho sempre fatto vivere la mia famiglia dignitosamente». Era povero e «quando sei povero non puoi scegliere nemmeno come scappare, devi scappare spendendo il meno possibile. E noi eravamo cinque». I fratelli di sua moglie avevano vissuto per un periodo a Bengasi, a est della Libia, avevano i nomi di chi avrebbe potuto aiutarli. Ibrahim racconta di aver contattato dei siriani per la prima parte del viaggio, e «poi quel gruppo di libici, che promettevano un posto su un barcone, dei giubbotti di salvataggio e di farci arrivare in Europa in sicurezza». Ibrahim scappava dalla guerra e avrebbe solo voluto poter dire ai suoi tre figli: vi prometto che potrete studiare, vi prometto che vi aiuterò a realizzare i vostri sogni. Però queste parole Ibrahim non poteva dirle. Oggi Ibrahim lavora come carpentiere in un cantiere edile a Misurata. Guadagna circa 700 dinari al mese. Che al cambio ufficiale sarebbero circa 600 euro, ma oggi il dinaro è carta straccia e al mercato nero 700 dinari valgono circa 150 euro.
La mattina Ibrahim esce di casa quando fuori è ancora buio, deve camminare chilometri per arrivare al cantiere, perché l’unica automobile che era riuscito a comprare dopo qualche mese di lavoro si è rotta e lui non ha i soldi per aggiustarla. Quando la mente ritorna ai ricordi del passato, Ibrahim dice: a volte penso che sarebbe meglio morire che continuare a vivere così. Lo dice mentre è seduto su uno sgabello di fronte all’entrata di casa sua, una stanza, un bagno e qualche pentola a terra. Una casa troppo fredda per affrontare le temperature insolitamente rigide dell’inverno libico.
Anja, sua moglie, ha trentotto anni. Ne dimostra almeno dieci di più. Ha il viso segnato dal dolore. I movimenti lenti e impacciati del suo corpo raccontano più delle sue parole quanto grande debba essere stato il suo lutto. Quello che ha vissuto negli ultimi due anni è uno strazio che in casa è diventato un tabù. Parlarne è impossibile, tanto meno elaborarlo.
«Quando siamo arrivati in Libia io ho sperato con tutte le mie forze che fosse l’ultima tappa della nostra fuga, prima dell’Italia» afferma la donna. Anja racconta che i trafficanti che hanno pagato li hanno tenuti per quindici giorni in una casa di cemento vicino al mare. Chiusi a chiave senza potere uscire. «Dicevano che dovevamo aspettare il tempo buono, ma il tempo era buono e la nostra stanza continuava a riempirsi di persone. Abbiamo capito con il passare dei giorni che non aspettavano il tempo buono, aspettavano di raggruppare il numero maggiore di persone, per guadagnare di più».
In quei quindici lunghissimi giorni il cibo arrivava a stento, così come l’acqua. I trafficanti passavano loro un po’ di formaggio e del pane dalle grate delle poche finestre presenti. Anja ricorda l’aria irrespirabile, la lotta con gli altri per ottenere un po’ di cibo. La privazione del cibo per garantirlo ai suoi tre bambini che continuavano a chiederle: Perché siamo qui?
«Poi una notte sono venuti a prelevarci, a gruppi di venti, forse trenta persone. Ci hanno fatto arrivare a riva e ci hanno portato sul barcone con dei gommoni. Quando ho visto il mare, il buio, ho sentito il rumore delle onde che si infrangevano sulla sabbia, ho guardato mio marito e gli ho detto: Ripensiamoci, non andiamo. Ho paura».
Aveva così paura Anja che ha cominciato a strillare, ma uno dei trafficanti l’ha trascinata sul gommone con i suoi figli. Quando sono arrivati sul barcone che avrebbe dovuto portarli in Europa, Anja ha assistito all’ennesima lotta degli ultimi del mondo. «Noi siriani eravano sopra, all’aria, potevamo pagare un poco di più e ci hanno munito di giubbotti di salvataggio. Poi, sottocoperta c’erano centinaia di ragazzi e ragazze e bambini e bambine di colore. Stipati, non respiravano».
Anja racconta che poco dopo la partenza, in piena notte, il barcone ha cominciato a imbarcare acqua, che l’allarme è arrivato proprio dai più sfortunati stipati sotto. «Hanno cominciato a gridare, a urlare allo scafista che stavamo imbarcando acqua, che rischiavamo di affondare e morire tutti. Ma lo scafista faceva finta di non sentire. Ha provato a tirare dritto».
In quel momento si consuma la tragedia. Lo scafista usa il suo telefono satellitare per chiamare a riva, i suoi complici raggiungono il barcone, caricano l’uomo per portarlo indietro, lasciando centinaia di persone in mare a cercare di sopravvivere tra le onde. Anja fatica a riportare alla mente quei momenti. Deglutisce, guarda a terra, maneggia nervosamente il suo telefono, le foto di suo figlio, del figlio che ha perduto sono solo lì. Poi trova coraggio e prosegue. «Mi sono gettata in acqua tenendo stretto il mio figlio più piccolo. Non ricordo niente. Non ho pensato a niente. Pregavo solo di sopravvivere, pregavo che sopravvivessimo tutti».
Anja è rimasta abbracciata a Bilal tutta la notte, un’intera notte in acqua a lottare tra la vita e la morte. Bilal le chiedeva quando avrebbero riposato, lei gli rispondeva: «Presto piccolo mio». Sapendo di mentire. Anja cercava un appoggio. Qualcuno, qualcosa che la sostenesse. «A momenti vedevo delle sfere, mi attaccavo, poi capivo che erano teste, che erano cadaveri». Dopo ore e ore in mare e un disperato tentativo di aiuto a un gommone che non si è fermato a raccogliere né i morti né i vivi, Anja è stata recuperata dalla guardia costiera libica. Condotta a riva con suo figlio, Bilal. Cercando quello che restava della sua famiglia.
Poi lo svenimento e l’ospedale. Tre giorni di flebo e paura. E le domande: dove sono i miei figli?
«»Dopo Anja, domani Anja, non preoccuparti Anja», continuavano a ripetermi tutti, e nessuno mi ha risposto per tre giorni. Finché non mi hanno mostrato la fotografia del corpo di mio figlio. Morto». Anja non vede il mare da allora, convive con il suo dolore, con il senso di colpa per aver portato i suoi figli su quel barcone. Per sollevarsi dal peso della responsabilità si è convinta che suo figlio sia stato ucciso da un altro migrante che voleva sottrargli il giubbotto di salvataggio per salvarsi. «C’era una ferita sul suo volto — dice la donna per giustificare i suoi pensieri — me l’hanno ucciso».
Anja non sostiene il peso del suo dolore. Non riesce a spiegarsi come sia possibile lasciare centinaia di persone a morire. Non riesce a perdonare se stessa per aver dovuto compiere la scelta che nessuna madre dovrebbe mai fare: prendere con sé un figlio per cercare di salvarlo e lasciare un altro figlio a se stesso sperando che si salvi da solo.
da Misurata
Francesca Mannocchi