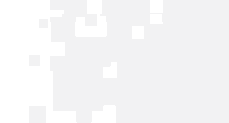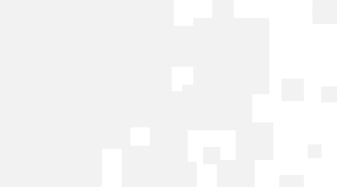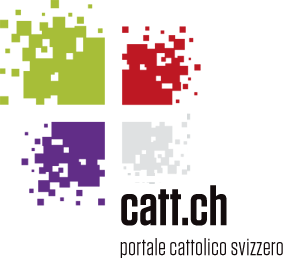Sulla poesia di Alda Merini: poesia ed esperienza della grazia
Prosegue la rubrica a cura del poeta Gilberto Isella, con la quale andiamo alla scoperta di testi significativi della tradizione italiana e europea. Questa volta la rubrica è dedicata alla figura di Alda Merini (1931-2009).
Alda Merini, una delle figure più prestigiose della poesia italiana contemporanea, muore settantottenne a Milano, sua città natale, nel 2009. È stata «la pazza della porta accanto», come l’hanno definita, o una santa laica? Molte iperboli si sono sprecate per lei.
Sta di fatto che la sua popolarità, ottenuta con pieno merito, non può essere disgiunta da una serie di vicende biografiche vissute con dolore e, allo stesso tempo, animate da un desiderio di riscatto attraverso la parola. Internata più volte in ospedali psichiatrici, Alda ha maturato una poesia profondamente debitrice di quell’esperienza: «Dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita».
Dove per vita bisogna intendere innanzitutto difesa del sé più autentico: attaccamento senza falsi pudori al proprio corpo, eros, amore per il prossimo (in particolare creature umili come la «lavandaia dalle gonne putride» o il «marocchino che vende le bambole») ed elevazione a Dio. Una sensualità estrema trascesa in follia mistica. Gli inguini, a questo riguardo, sono «la forza dell’anima», poiché è facile perdersi «nella giungla dei sensi,/ asfaltare l’anima di veleno/ ma dagli inguini può germogliare Dio». La Merini è autrice di innumerevoli raccolte (da La presenza di Orfeo, 1953 a I poeti lavorano di notte, 2009) tutte significative, anche se a mio giudizio il capolavoro rimane La Terra Santa, pubblicata da Scheiwiller nel 1984. I versi citati sopra appartengono a questo libro, così come il componimento Io mi sono una donna dedicato a Salvatore Quasimodo, che propongo ai lettori. Qui la metrica, appoggiata all’endecasillabo, segue la tradizione.
Quanto al contenuto, esso colpisce per la sua dolorifica effervescenza. Dopo i primi due versi di sapore quasi dantesco («Io mi sono una donna»), esplode, in negativo e dunque per antifrasi, l’orgoglio trattenuto ma non rimosso di una creatura ingiustamente reietta: «disprezza», «dispetto», «furore», fino al successivo crescendo di «calpestata, derisa, sputacchiata».
Vale a dire quando, al centro del testo, l’elemento religioso prende il sopravvento. Sapendo di dover affrontare un martirio, l’io si rifà apertamente all’imitatio Christi: «Sono un’anima appesa ad una croce», ed è chiaro che questa personale croce allude alle torture manicomiali, descritte in modo toccante in un testo parallelo: «E, dopo, quando amavamo,/ci facevano gli elettrochoc/ perché, dicevano, un pazzo/ non può amare nessuno».
Ormai scissa dalla propria armatura carnale, alla condannata non restano che gli occhi: occhi che gridano e implorano la grazia divina.
«Io mi sono una donna che dispera»
Io mi sono una donna che dispera
che non ha pace in nessun luogo mai,
che la gente disprezza, che i passanti
guardano con dispetto e con furore;
sono un’anima appesa ad una croce
calpestata, derisa, sputacchiata:
mi sono rimasti solo gli occhi ormai
che io levo nel cielo a Te gridando:
toglimi dal mio grembo ogni sospiro!