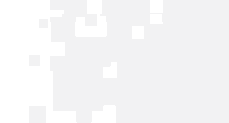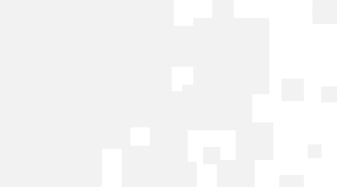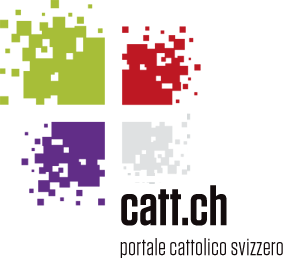Il Sud Sudan al collasso, l’impegno della Chiesa in mezzo a guerre e carestia
Nella giornata del 16 aprile scorso, il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, ha espresso «profonda preoccupazione per il protrarsi delle violenze, per le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani nel Sud Sudan». La nota dell’organismo europeo, giunge a qualche settimana di distanza dalla dura denuncia a firma della Commissione per i diritti umani dell’Onu riguardo la situazione nel Paese. Nel documento si parla di reclutamento forzato di bambini – costretti ripetutamente a uccidere civili – di massacri e razzie, distruzione di ospedali, scuole e abitazioni e di «azioni di pulizia etnica, stupri di massa, mutilazioni e villaggi interi dati alle fiamme».
Sempre il 16 aprile, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in un rapporto sulla situazione del Sud Sudan ha denunciato il fenomeno degli stupri come strumento di guerra etnica in molte zone del Paese. I vari organismi sovranazionali, fotografano senza dubbio il drammatico momento del Paese ma, al tempo stesso, sembrano certificare l’impotenza della comunità internazionale di fronte a una delle crisi più tragiche degli ultimi anni.
La guerra civile nella Repubblica più giovane del mondo – ha raggiunto l’indipendenza dal Sudan nel 2011 – va avanti da oltre quattro anni. L’invio di 17mila Caschi blu il cui mandato il 15 marzo scorso è stato rinnovato per un altro anno, ha avuto fin qui risultati molto limitati e le speranze riposte neltentativo del 22 dicembre scorso di riesumare gli accordi di pace (siglati dal governo di Salva Kiir e dalle forze di opposizione di Riek Machar ad Addis Abeba nell’agosto 2015), sono ormai tristemente svanite.
«In Sud Sudan – spiega suor Yudith Pereira-Rico, direttrice esecutiva di «Solidarity with South Sudan», un organismo che raccoglie varie congregazioni religiose e lavora in collaborazione con la Conferenza episcopale locale – si concentrano tutte le tragedie del mondo: guerra, inflazione, stipendi non pagati da più di un anno e mezzo, mancanza di strutture, fame, carestia. Oltre 3 milioni di abitanti sono fuggiti. Fino a qualche anno fa c’erano 12 milioni di persone, ora meno di nove e, di questi, sette si trovano in emergenza umanitaria. Se si eccettua un’infima minoranza di figli delle famiglie al potere, la totalità degli altri bambini è alla fame. A dicembre si è tenuto l’ennesimo colloquio ad Addis Abeba ma più che di un tavolo di pace si è trattato di un incontro volto solo ad assicurare la spartizione del potere. Gli Usa parlano di imporre sanzioni contro il Sud Sudan: alla fine mi sono convinta che sia l’unica via. Gli Stati Uniti erogano molti finanziamenti e se i rubinetti si chiudono, i leader politici saranno costretti a trovare un accordo. In ogni caso, il vero problema è il continuo afflusso di armi. Questo Paese si è trasformato in infinito mercato di armi e ogni volta che alle Nazioni Unite si propone l’embargo, c’è sempre qualcuno che lo blocca. Una volta è la Russia, un’altra è Israele ed è lo stesso per altri Paesi».
La guerra ha messo in ginocchio l’economia: «C’è il 900% di inflazione, non si compra più nulla. Stiamo assistendo a un crollo economico totale. Al momento tutte le tribù sono in guerra e tra queste ve ne sono alcune che tradizionalmente non hanno mai preso un’arma in mano. La situazione spinge ogni giorno qualcuno a fare la guerra contro qualcun altro. Le milizie sono totalmente incontrollate e agiscono sulla base della fame e della ricerca di denaro».
La giovane nazione, nata solo poco più di sette anni fa, rischia di soccombere. Sul banco degli imputati, in primo luogo, siede l’intera classe politica accusata di totale incapacità nella gestione del processo democratico. «C’è bisogno di una classe politica che venga dalla società civile, per governare il Paese – riprende suor Yudith -. Ancora meglio sarebbe se emergesse una classe dirigente femminile: le donne vedono le cose in maniera diversa e potrebbero disegnare meglio degli uomini un progetto di pace. Non c’è ancora una coscienza nazionale, una mentalità del bene comune. Noi, da quando siamo arrivati in Sud Sudan dieci anni fa, in tutte le istituzioni che gestiamo, insistiamo sul concetto di convivenza civile: si può vivere insieme, anche se differenti.Abbiamo formato almeno 3000 insegnanti e tantissimi operatori sanitari e sono loro, credo, la speranza del futuro del paese. Ma bisogna evitare che fuggano e mettere fine al conflitto prima che sia troppo tardi».
Creato dalle Unioni delle Superiore e dei Superiori Generali, Solidarity with South Sudan nasce come risposta alla chiamata dei vescovi sud sudanesi ad aprire missioni nel Paese. Poiché le candidature delle singole congregazioni tardavano a venire, è stato proposto di garantire una presenza stabile intercongregazionale. «È il nostro valore aggiunto – sottolinea la suora – siamo una comunità composta da 30 religiosi, uomini e donne, che vivono in cinque località sparse in Sud Sudan. I nostri ordini, le realtà, le provenienze e le culture sono molto diverse tra loro, ma lavoriamo insieme per amore di questo Paese martoriato».
«Qui – aggiunge – ci sono molte Ong che offrono servizi fondamentali per l’emergenza, danno cibo, pensano alle cure mediche. Noi invece stiamo qui stabilmente e possiamo puntare allo sviluppo. Ci occupiamo di scuole, ospedali, facciamo formazione di infermieri e ostetriche, di insegnanti, progetti a lungo termine. Gestiamo un campo profughi spontaneo con 5000 persone. Abbiamo molti motivi per sperare in un futuro diverso e in un ritorno dei tanti che sono fuggiti. Ma se non si procede a un immediato embargo delle armi e a un colloquio di pace autentico, le speranze resteranno tali».