
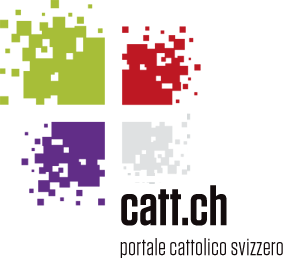
Ci apre lui stesso, l’architetto conosciuto in tutto il mondo. La sua vita è rimasta semplice, come spesso avviene nel microcosmo elvetico in cui tutto è a misura d’uomo, senza eccessi. La sveglia alle sei, il caffè al solito bar, il lavoro in studio fino al tramonto, la sera prevalentemente a casa. Mario Botta ci viene incontro con una cordialità paterna e la praticità di chi si muove nel proprio ambiente. Entriamo.
Lo spazio, disegnato dalla sua mano, ha l’impronta equilibrata di molte sue costruzioni; la luce filtrata da elementi metallici che separano dolcemente il dentro dal fuori. Davanti a noi una ventina di tavoli da lavoro, tra i quali il maestro spiega di non averne uno proprio: guardando ai due universitari che mi accompagnano, descrive il suo quotidiano passare di tavolo in tavolo, intervenendo a osservare, correggere, suggerire soluzioni. Un metodo che investe sui giovani collaboratori e lascia loro spazio, in una graduale trasmissione del sapere pratico maturato in decenni di progettazione.
Circondati da tavole che rinviano a cantieri in ogni angolo del pianeta, iniziamo a conversare e chiedo come sia possibile costruire dappertutto essendo insieme rispettosi della cultura altrui, del contesto, del genius loci. Non è difficile osservare che, quando interviene, Botta è Botta: gli edifici portano in sé il suo linguaggio, la sua impronta. «Le forme che io do sono forme non mie e stanno nella matita, più che nella mia testa. Lei dice «Botta è Botta», quindi coglie un’identità di immagine formale: il segno personale, che necessariamente è tale. Picasso ha il suo segno e lui stesso ne è vincolato. È chiaro: ognuno esprime la propria esperienza, i suoi interessi, però quel che lascia sul territorio credo sia un’interpretazione del proprio tempo storico. L’architettura è interessante perché non può parlare se non del proprio tempo, ne è una forma espressiva. Per esempio, fare una chiesa dopo Picasso o Duchamp, che cosa significa? Fino a Rudolf Schwarz e a Romano Guardini vi era un’evoluzione relativamente lenta dell’immagine. Poi sono arrivate le avanguardie artistiche e hanno sconvolto il nostro senso estetico e anche quello etico. E quindi come dare un luogo di silenzio e di preghiera oggi? L’architettura ha ancora la possibilità di tradurre in forma, in spazio e quindi in luce, una condizione storica. C’è una sorta di spinta irrazionale, come una forma di libido che l’architetto ha nel costruire; e tu devi costruire per contribuire alla Weltanschauung, a una visione generale del mondo. Attraverso il costruire tu testimoni di essere cittadino di un determinato tempo storico. Perciò si pongono dei problemi, degli interrogativi: ad esempio, che cos’è oggi uno spazio di preghiera? Perché abbiamo bisogno ancora, di trovare un luogo fisico dove pregare?».
A colpire Botta, nell’accostarsi al sacro, è anzitutto un senso di secolare permanenza. Egli osserva che, se negli altri temi architettonici a un bisogno costante — di casa, di teatro, di biblioteca, di fabbrica — sono corrisposti notevoli mutamenti di struttura e di funzioni, «lo spazio sacro, nella cultura cristiano-occidentale, da duemila anni continua ad accostare il popolo dei fedeli a un altare: è una forza incredibile, qualcosa di millenario che ha superato tutte le trasformazioni, le rivoluzioni, le guerre, il cambiamento delle ideologie. Anche sulla sponda di un fiume si può fare un’esperienza devozionale, ma nel luogo di preghiera io ho bisogno di essere accanto ad altri per condividere ciò che supera l’individualismo. È ciò che si avverte immediatamente in ogni luogo di culto attraverso il canto. Un bisogno primordiale che curiosamente oggi è il meno riconosciuto, sebbene nell’architettura esso permanga con la propria tipologia».
Botta intravvede in questa esigenza di radunarsi una sorta di fil rougeche attraversa «la cultura di Abramo», l’elemento trasversale alla progettazione delle sue chiese, di una sinagoga, ora di una moschea. E confessa: «Fosse per me, ormai farei solo sacro»: quando, infatti, dalle domande parziali cui rispondono le altre tipologie di edificio, si passa alla questione più radicale del senso, allora l’architetto è sfidato nel più profondo della sua professionalità.
Lo spazio sacro, paradossalmente, non gli impone di diventare più religioso, ma più architetto, perché investe di una domanda totale le fondamenta stesse del costruire. «Devo dire che attraverso il sacro ho ritrovato i valori dell’architettura: l’idea di gravità, di limite, di soglia, l’idea della luce come generatrice dello spazio, cioè gli elementi fondativi del fatto architettonico mi sono stati rivelati dallo spazio di culto in maniera molto più forte che non dagli altri». Si tratta, quindi, di una rifondazione del gesto umano, di una riscoperta della sua densità simbolica in grado di liberare l’esperienza del costruire e dell’abitare dai propri abbrutimenti. «Quando vedo le interpretazioni date oggi dei supermercati non so più cosa vogliano dire il colore, il laser, le luci, le merci, gli odori… Allora ho bisogno di tornare agli elementi fondativi. È la forza del romanico: basta una piccola cappella e riconosco quel filone che ha attraversato mille anni di storia e che rimane estremamente eloquente».
Eppure, osserva Botta, proprio a questo livello «la cultura cattolica arranca». Non coglie cioè la formidabile opportunità di interrogare i nostri contemporanei su ciò che permane, di lasciare emergere la posta in gioco nel fare umano, altrimenti convulso e disarticolato. «Non so personalmente se io sia credente o no: credo nell’architettura, questo è sicuro. Ad esempio, quando Le Corbusier fa la cappella di Ronchamp — che cambia una cultura epocale — lui, protestante calvinista, realizza un inno alla Vergine e costruisce l’elemento che nel ventesimo secolo ne è la più bella testimonianza. Gli domandano i giornalisti, alla fine, se lui creda o no e lui risponde — è scritto nel libretto di Jean Petit su Ronchamp — «vi do una pedata nel sedere», perché è talmente paradossale questa domanda… Io mi esprimo in questo modo e tu vuoi sapere altro. Ma cosa t’importa del mio intimo e se pratico o non pratico? Io ho imparato e anche un po’ radicalizzato questo pudore: mi è costato tantissimo, sono stato anche martoriato. Il cardinale Jean-Marie Lustiger, quando ho lavorato per la cattedrale di Evry mi ha detto: «Separa sempre il problema della tua fede da quello dell’elaborazione professionale, perché in nome della presunta adesione ideologica si sono costruiti dei mostri»: prendevano degli architetti non perché erano bravi professionisti, ma perché erano bravi praticanti, bravi cattolici, e hanno permesso loro di fare le cose peggiori del Novecento. Resistere non è facile: io ho trattato con tanti vescovi e non è semplice, perché devono digerire l’andare a fare un’operazione dal medico che ha la conoscenza e la sapienza del proprio tempo, convinti però che un barbiere medievale possa operare meglio. In questo, devo dire, mi sono trovato un po’ contro mia moglie, praticante convinta: io però non mollo, perché mi sembrerebbe di tradire veramente la Chiesa».
A trent’anni dal primo progetto — la controversa ricostruzione della parrocchiale di Mogno — percepiamo il rapporto sofferto, ma vivo, con una committenza spesso confusa: «Una capanna: devi scrivere «Questa è la chiesa» per riconoscere che è una chiesa? O c’è qualcos’altro che può dirlo? Nelle vecchie cascine bastava il piccolo segno di una croce per dire quale era la chiesa e quale la stalla: occorre pochissimo, non la grande retorica. E perché? Perché dentro io ritrovo anche tipologicamente una struttura primitiva, molto semplice: luogo del sacrificio, luogo della parola e popolo dei fedeli».
Osservo che l’elemento chiave del nostro confronto, da mettere più urgentemente in circolo nella Chiesa cattolica, è l’uscita da un approccio ideologico all’architettura sacra, quello che del costruire ha ancora un’idea molto aneddotica: «Secondo me è importante si sappia che l’architettura ha qualcosa di suo da dire, anche dal punto di vista teologico. Io la considero come un antidoto all’interpretazione disinvolta, alla stupidità. L’architettura ha delle ragioni. Un muro è un muro e al di là del muro c’è altro: è una separazione e non si può dire che non lo sia. La soglia è un niente, un filo virtuale, però da una parte c’è una realtà esterna, il mondo intero, e dall’altra c’è l’ecclesia, lo spirito stesso. L’architettura porta con sé l’idea del limite: il suo primo atto è quello di disegnare un perimetro; fuori c’è l’immensità del mondo e dentro c’è quello che io, architetto, voglio per esprimere una casa, una fabbrica, un museo, una chiesa. Al di là del fatto che si trasforma così una condizione di natura in una di cultura, proprio il dover separare un contesto da un altro porta con sé l’idea del sacro.
L’assegnazione del premio Ratzinger, faccio notare, costituisce allora un riconoscimento sorprendente: è il sì all’approccio tutt’altro che servile di un architetto serio, la conferma di una dignità interna al gesto artistico, di cui la Chiesa arriva a riconoscersi debitrice. Botta ammette sorpresa e commozione, quasi ripagato di tante incomprensioni. «Nella storia breve del Novecento Guardini e Schwarz hanno dato testimonianza di quanto io credo. Sono le chiese più belle del XX secolo, quelle nate dal loro straordinario sodalizio: il teologo era teologo e l’architetto architetto. Dopo quegli anni che cosa abbiamo fatto? Se scrivessi la storia delle architetture di culto, troverei in Italia il peggio della produzione mondiale, perché ha prevalso l’idea della bizzarria, la frustrazione degli architetti che invece di attingere dalla storia hanno dato corso a ogni stravaganza. Ci sono chiese di una bruttezza indicibile: mancano di un senso. Devo dire che c’è molta confusione anche nella gerarchia ecclesiale: io non ho mai sentito parlare così male di come costruire chiese quanto da cardinali e da monsignori, perché tutti lì s’inventano architetti, senza una specifica cultura. Una volta, per le chiese romaniche prendevano i capomastri: non era il vescovo che andava a dire come costruirle».
È interessante come, a partire dall’insistenza sulla professionalità dell’architetto, Botta arrivi a descrivere sempre più lucidamente il cuore del mistero cristiano, a conferma che non l’impegno a una traduzione didascalica delle verità di fede, ma la considerazione del loro impatto sulla realtà sia condizione di riuscita di un progetto. «A me impressiona sempre il momento di silenzio, all’elevazione del pane e del calice: c’è come una tensione che viene ad acuirsi, per lasciar spazio all’interpretazione, dove ognuno non solo vede, ma diviene parte. Il fedele diventa parte di ciò che celebra: come rappresentare questo spazio dell’altare in modo proporzionato a quel momento? Quale qualità architettonica offre la possibilità di immedesimarsi in un simile atto, che si ripete sempre nuovo da duemila anni? Sono questi i problemi della disciplina, di cui è forse giusto che il fedele non si renda conto, ma che l’architettura deve affrontare».
Ci si accorge che, in tre decenni di lavoro sul sacro, Mario Botta è cambiato. In fondo, umanamente è naturale: ciò con cui ci rapportiamo, le esperienze in cui ci cimentiamo sfidano ciò che inizialmente eravamo. Tutto il suo racconto colpisce i giovani che mi accompagnano per la profondità che comunica. Non c’è ripetizione, ma una progressiva chiarificazione: il venire alla luce, operativo prima che teorico, dei fondamenti dell’umano. È infatti l’intera personalità del grande architetto a rivelarsi toccata da ciò cui ha dato forma. Beatrice, futuro architetto, osserva fra le mani del maestro, mai ferma, una matita rossa che lo accompagna dappertutto. «Devo dire che mi aiuta a pensare. È come il prolungamento del pensiero per l’architetto. Poi — è curioso — io uso la matita non per rappresentare, ma per cercare qualcosa: parto sempre da uno schizzo e la matita, il segno della matita, porta con sé una speranza».
Botta ci invita quindi a tavola, quasi a sigillare la continuità tra costruzione di spazi e di legami. Gli uni e gli altri vivono di limiti e di apertura: l’abc dell’architettura è il cuore del mistero.
(Osservatore Romano)
Chiesa cattolica svizzera
https://www.catt.ch/newsi/i-vincitori-del-premio-ratzinger-in-dialogo-con-mario-botta/