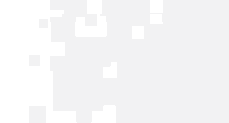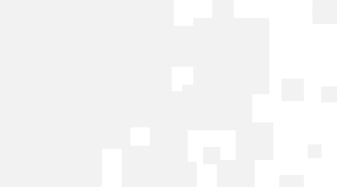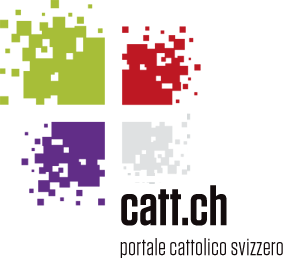Serve una Chiesa che si mostri bisognosa di perdono
La Chiesa oggi ha bisogno di mostrarsi per ciò che è, «perdonata e sempre bisognosa di perdono», per annunciare a tutti che c’è la possibilità di essere ascoltati, accolti e perdonati con misericordia. L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, seduto alla scrivania del suo studio nel palazzo che domina piazza Fiera, racconta a Vatican Insider gioie, sorprese e difficoltà del suo primo anno di episcopato alla guida di una diocesi della quale, nei dieci anni precedenti, era stato vicario generale. «Mi sento profondamente inadeguato, mi son trovato questa nomina che assolutamente non prevedevo, dopo dieci anni da vicario sognavo di andare in parrocchia».
Lei si è insediato nell’aprile 2016: com’è stato questo primo anno di episcopato?
«È stato un anno buono, avevo la preoccupazione di non essere all’altezza del compito, e questa continua a esserci, mi rendo conto che essere vescovo non è un onore ma una responsabilità. Però devo dire di aver trovato nel clero e nelle comunità tante belle sorprese».
Sorprese? Scusi, la diocesi non la conosceva già?
«Per la mia diocesi ho sempre nutrito stima e affetto, è una realtà particolare, di montagna, ed è piccola: siamo come un quartiere di Milano, 500 mila abitanti, meno di Sesto San Giovanni. Abbiamo un senso di appartenenza molto radicato, siamo persone che sentono molto il territorio. Una specie di rivendicazione un po’ identitaria, che secondo me non fa male. Io ho paura di quelli che non amano il campanile, basta che non lo si usi contro gli altri, in tal caso fa solo male. Quando l’identità si apre diventa una risorsa. È vero che conoscevo la diocesi, eppure Dio mi ha sconvolto con tante sorprese che non avevo pensato né preparato».
Cominciamo dalla prima, qual è?
«Io mai avrei sopportato di celebrare la messa quotidiana da solo. Sono sempre stato abituato a celebrare in comunità. Diventato vescovo mi son detto che dovevo trovare il modo di continuare a celebrare ogni giorno con la gente. Un sacerdote che segue gli universitari mi ha proposto di invitarne alcuni per la celebrazione alla mattina. E dall’aprile dell’anno scorso questo appuntamento non si è mai interrotto. Ogni mattina circa 15-20 universitari partecipano alla messa, io dico un breve pensiero come omelia, loro presentano preghiere spontanee. Alcuni di questi giovani hanno riscoperto la messa, perché prima non ci andavano».
Lei parla spesso del «Dio capovolto». Che cosa significa?
«Fin dal giorno della mia nomina è qualcosa che mi è venuto fuori quasi per caso: ho detto che noi dobbiamo parlare di un «Dio capovoltoˮ. E questo è diventato un po’ il mio leitmotiv. Credo che ci sia bisogno di raccontare Dio a partire dall’umanità di Gesù Cristo. Siamo abituati a raccontare Dio in modo troppo astratto e filosofico. Dobbiamo imparare a passare dall’umanità di Cristo per narrare Dio. Non è mica una scoperta mia: basta leggere il Vangelo, basta leggere santa Teresa d’Avila o san Francesco d’Assisi. E gioisco ogni giorno per l’approccio del Papa, che sa parlare così di Dio. Ai giovani dobbiamo dire: a volte siete lontani dalla Chiesa perché Dio vi viene raccontato in modo improprio, magari in termini corretti, ma che vi tengono a distanza».
I giovani sono un’altra delle sue priorità, non solo per la messa mattutina. Come si annuncia il Vangelo a loro?
«Appunto partendo dall’umanità di Gesù Cristo. I giovani sono i veri poveri di questo momento, la loro è diventata categoria esistenziale. Vorrei tanto che tornasse una stagione della vita. Oggi i giovani non hanno voce e non sono ascoltati, si parla su di loro ma non gli si dà spazio. Un’altra delle sorprese che Dio mi ha fatto è un’iniziativa, Passi di Vangelo, che non è nata da me, ma dal clero giovane. Incontri di preghiera durante i quali io propongo una riflessione di venti minuti su un brano evangelico. Poi i gruppi riprendono durante il mese quel testo. Mi ha colpito la partecipazione: 330-340 giovani alla volta, con persone che venivano da tutte le valli. Per la nostra realtà sono numeri sorprendenti. È Dio che mi prepara delle cose, io non ho pensato nulla, sono stati i preti giovani… A loro racconto questo «Dio capovoltoˮ».
Come ha organizzato il suo lavoro?
«Volevo uscire dal mio ruolo precedente, e ho trovato che la via del camminare insieme e della corresponsabilità sia la più indicata. Ho nominato un piccolo consiglio episcopale e ogni lunedì ci troviamo per tutto il pomeriggio, a discutere delle varie questioni. Non decido da solo. Abbiamo rinnovato gli organismi del consiglio presbiterale e del consiglio pastorale diocesano. Con una scelta che inizialmente io temevo, anche questa suggerita dai miei sacerdoti: quella del rinnovamento. Abbiamo chiesto di farsi da parte a chi ricopriva un incarico in questi organismi da più di dieci anni. Avendo noi poco clero, già da tempo abbiamo costituito grandi unità pastorali. Ci sono preti che devono occuparsi anche di 12-17 parrocchie sparse nei vari paesini. Ogni comunità si nomina un gruppetto di responsabili che si occupa dell’organizzazione della vita della comunità. Ogni cinque anni c’è l’elezione dei comitati e ogni dieci anni bisogna lasciare il posto».
Il suo progetto pastorale?
«Non l’ho fatto, e spero di non doverlo mai fare. Sto andando avanti così, con serenità. Non ho progettato, mi sono trovato di fronte a questi fatti, e qui emerge un metodo, quello indicato nell’esortazione apostolica «Evangelii gaudiumˮ: la realtà prima delle idee. Dobbiamo finire, io credo, con la pastorale dei temi, dei percorsi un po’ troppo astratti. Bisogna partire dai dati concreti e lasciarsi portare dalla realtà per raccontare un Dio bello e interessante. Dobbiamo investire in positività senza spaventarci del calo dei numeri. Dobbiamo alimentare speranza e la speranza ti viene se ti fidi della realtà».
Come si può oggi annunciare il Vangelo toccando il cuore delle persone, al di là del semplice enunciato di un messaggio?
«Certamente non con una narrazione accademica o solo catechistica, ma frequentando la gente. Senza aver paura delle persone, delle loro storie accidentate. Bisogna andare con la fiducia, con la certezza che comunque quel terreno è abitato da Dio. Dobbiamo superare l’idea dei recinti e dei territori sacri, anche l’idea dei terreni puliti: il terreno umano è sempre pulito e allo stesso tempo sporco. E allora ecco un altro tema importante, quello della sobrietà e di una Chiesa che si mostri con il volto della vicinanza, della prossimità e della povertà. Penso che per i prossimi anni il nostro obiettivo sia questo: rimettere in gioco le nostre strutture. Già prima che diventassi vescovo in diocesi c’erano 21 canoniche messe a disposizione di situazioni di disagio e di povertà. Devo dire che questo è servito di più di tante catechesi. La gente vede che la canonica – ne abbiamo tante disabitate nei paesi – è andata a soccorrere un disagio, a ospitare profughi o persone con disagio psichico. Il fatto che l’abbiamo fatto non è diventato solo una buona notizia. A volte, dopo le prime comprensibili paure, è accaduto che il paese si sia rimesso in gioco».
Quanto è importante la capacità di testimoniare prossimità e accoglienza?
«Senza questo stile non si va da nessuna parte. Come vescovi e preti dobbiamo essere più accessibili e non scandalizzarsi delle storie delle persone. Questo non vuol dire, ovviamente, santificare e benedire tutto. Perché è chiaro che va fatto un discernimento. Però dobbiamo essere coscienti che nessuna storia è mai maledetta, ogni storia è abitata da Dio. Se io l’affronto con questo spirito, sono le stesse persone che incontro a riconoscere di essere fuori dal binario. Tante persone che sono ai margini non sono ai margini dell’umano, sono ai margini perché la storia li ha portati lì e non sanno più da che parte voltarsi. Bisogna parlar loro di un Dio che include, che ti raggiunge nella tua realtà, ti riscatta. È bellissima questa intuizione di Papa Francesco: dobbiamo avviare processi, non esibire medaglie o decorazioni».
Che cosa intende quando parla di una Chiesa che non «esibisce medaglie»?
«Mi piace l’idea di una Chiesa che offre il perdono dicendo: io sono stata perdonata. Non una Chiesa che dice: io sono a posto. Se si declina questo esistenzialmente, cambia il passo, perché non ho più bisogno di esibire le mie grandezze o la mia perfezione, ma la mia prossimità. Non mi chiamo fuori dalla realtà di peccato che ci riguarda tutti. Se pensiamo di mostrarci come la cittadella sul monte che non ha smagliature, questo non funziona. E allora perché non dire come faceva don Lorenzo Milani: rimango nella Chiesa perché ho bisogno del perdono. Una Chiesa che ha sperimentato sulla sua pelle di non essere stata respinta, ma sempre continuamente lavata e perdonata. Mi piacerebbe che questo sguardo entrasse sempre di più nella prassi e nell’approccio pastorale».
Secondo lei oggi c’è ancora il rischio del clericalismo?
«Credo che sia necessario superare lo schema preti-laici, che è divisivo, per mettere invece al centro la vita della comunità. Il soggetto evangelizzante è una fraternità cristiana che non si crede perfetta, che ha bisogno di perdono e che pone gesti di prossimità. È finito il regime di cristianità. Abbiamo bisogno di comunità, uomini e donne che vivendo la dinamica di Gesù accolgono il ferito e dicono: guarda che sono stato ferito anch’io. Uomini e donne che si muovono in un’ottica di fraternità. La fede è l’incontro con una persona, non una dottrina o un’etica. Mi piacerebbe riformare la struttura diocesana, e non agire più per ambiti, ma parlare di vita, dei giovani, della famiglia, del lavoro, non solo di un ambito, sennò si producono fissazioni e astrattezze. Si producono ambiti separati che vanno ognuno per conto proprio. Lo dico sempre alla Caritas: vorrei quasi che il vostro nome scomparisse come nome, e fosse la Chiesa di Trento che si fa carico dei poveri. Non ci sono gli addetti per la carità, per la famiglia, per i problemi del lavoro. C’è una comunità che incontra i bisogni. La vita delle persone non è divisa in settori».
Il Papa dice che si va in periferia non per evangelizzare ma per essere evangelizzati, per scoprire il volto di Gesù in chi soffre nel corpo e nello spirito.
«Dio abita nella storia, lo spirito di Dio è dappertutto, non esiste terra da cui è escluso, anche le terre più martoriate sono piene di Dio e di gente che si soccorre. Mi ha molto colpito il fatto che i cristiani di Erbil abbiano mandato un aiuto ai terremotati di Amatrice. Anch’io in quest’anno ho incontrato un Dio che era già passato dove arrivavo io. Il mio progetto pastorale è stare nella realtà che è piena di miracoli anche se spesso noi non li vediamo. Ho scelto di non avere un segretario che mi accompagna, quando la domenica visito le parrocchie mi nuovo da solo, e arrivo in anticipo per poter incontrare la gente. Torno a casa sempre contento perché non c’è volta che non mi sia stato regalato un racconto di storia sacra. Credo che sia rischioso per un vescovo stare nel palazzo e pianificare tutto con le statistiche e gli indicatori sociali. Quando sto qui dentro un po’ troppo, sento che devo andare e torno indietro con la vita. Altrimenti rischi di diventare un burocrate che studia piani virtuali».
A proposito di virtuale, che ne pensa del mondo digitale, dei social, e di come la Chiesa lo utilizza?
«Devo confessarle che sono restio a tutto il mondo del virtuale. Capisco che è un’opportunità straordinaria, non denigro certo i social, so che anche la realtà virtuale è abitata da Dio. Però a volte i social ci stanno togliendo la vita: non dobbiamo stare connessi H24, ma avere spazi di silenzio. Badi bene, non sto parlando di un silenzio da vendere come prodotto religioso, ma semplicemente come igiene umana. Tutto quello che si potrà fare come Chiesa per porre gesti di incontro reale sarà veramente una profezia. Perché nell’era del digitale come Chiesa potremo offrire degli spazi di umano concreto di cui il mondo ha bisogno…».
Senza contare che spesso c’è il rischio del funzionalismo, del credere che sei tu Chiesa a diventare protagonista con le tue bravure così simili a strategie di marketing…
«Quello del funzionalismo è un grande pericolo per la Chiesa. Ci vuole invece una Chiesa della strada!».
Lei ha parlato delle strutture, che spesso diventa difficile mantenere. Come pensa di fare?
«La possiamo vedere come una maledizione: non possiamo più permetterci di tenere queste grandi strutture. Io invece la considero una benedizione! Non dimentichiamoci che Israele è diventato grande nel tempo dell’esilio. Dobbiamo avere il coraggio di ridurre, il coraggio della sobrietà, e vedere questa situazione come una chiamata a un altro modo di essere Chiesa. Possiamo trasformare il peso enorme delle strutture, non solo materiali ma anche organizzative, educative. Per me è una benedizione che Dio ce le tolga per farci tornare al Vangelo. Su questo avevo letto un bellissimo intervento di Benedetto XVI a Friburgo, quando nel 2011 parlò di una «Chiesa soddisfatta di se stessa, che si accomoda in questo mondo, è autosufficiente e si adatta ai criteri del mondo». Una Chiesa che «non di rado dà così all’organizzazione e all’istituzionalizzazione un’importanza maggiore che non alla sua chiamata all’essere aperta verso Dio e ad un aprire il mondo verso il prossimoˮ. Una Chiesa che dovrebbe liberarsi «dai fardelli e dai privilegi materiali e politiciˮ per «dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo interoˮ ed essere «veramente aperta al mondoˮ. Dobbiamo uscire da un approccio emergenziale, fatto di rimpianti e di lamentazioni per la mancanza di preti, per quanti eravamo un tempo. Non sto giudicando, dico però che dobbiamo uscire da questa prospettiva «dell’eravamoˮ, dell’emergenza continua, investendo in speranza e fiducia. I preti più contenti che io ho vivono nelle unità pastorali. Il prete più contento è uno che sette anni fa, quando aveva 33 anni, con un azzardo, è andato a occuparsi di 13 diverse parrocchiette, in tutto sono soltanto 6000 abitanti, ma spostarsi da un posto all’altro nelle valli è un problema. È un prete felice: la gente gli ha comperato la macchina, un anno fa gli hanno fatto trovare la macchina nuova fuori dalla chiesa. Dipende da come tu stai dentro la realtà, con speranza senza catastrofismi».
Nel 1929, in un editoriale su Azione Fucina, Giovanni Battista Montini scriveva che il cristiano guarda al mondo non come a un abisso di perdizione, ma come a un campo di messe…
«Non conoscevo questa citazione. Io dico sempre, commentando le parole di Gesù «la messe è molta e gli operai sono pochiˮ: il messaggio qui non è che gli operai sono pochi ma è che la messe è molta, cioè nel mondo c’è molta vita. Una chiesa che non sia autoreferenziale e che pensi che ha bisogno degli altri, una Chiesa che si mette in gioco con tutti. Capace di fare rete con tutti. E mi diventa allora evidente il bisogno di una Chiesa che prega: abbiamo una Chiesa che fa liturgie ma non una Chiesa che prega. Quando il Papa ricorda che il vescovo deve innanzitutto pregare, è azzeccatissimo. Serve una Chiesa che torni a frequentare l’esperienza della preghiera per percepire la presenza di un Vivente che l’accompagna. Non di idee o di valori. Gesù non è un maestro di idee. Serve una chiesa che faccia un po’ di meno e preghi un po’ di più. Noi non abbiamo bisogno di operatori pastorali ma di testimoni, non di catechiste, ma di innamorati di Gesù».
Come è stata percepita a Trento l’esortazione «Amoris Laetitiaˮ?
«Il mio clero l’ha recepita molto bene. È vista come una grande opportunità, non ho riscontrato resistenze».
C’è il carico pesante del discernimento affidato ai sacerdoti…
«Io vedo il regalo più della fatica dell’impegno. Ho fatto per 12 anni il padre spirituale, nel discernimento non c’è mai il bianco e il nero, ma un cammino. È un problema non di fatica, ma di far sì che questo diventi davvero il metodo ecclesiale, il sistema di vita su tutto, non soltanto per i problemi della coppia. Il mistero dell’uomo non puoi fissarlo nei prontuari o nei manuali. Questa è una visione di Dio povera, che cerca un quadro etico con tutti gli elementi a posto, e non il Dio incandescente che ogni giorno ti dice: alzati e diventa prossimo dell’altro! Voler avere la regola che risolve tutto vuol dire aver capito poco dell’umano. La regola del tutto chiaro e distinto è casistica, ma non è la vita. Rischia di diventare ideologia. Vedo in Amoris laetitia un’opportunità molto bella. Ascoltare il vissuto dell’altro, ogni storia… Ma poi chi è irregolare? Chi è che può definirsi regolare? Siamo tutti irregolari, perché siamo tutti peccatori».
Un’ultima domanda. Quali sono state le difficoltà di questo primo anno?
«Innanzitutto, la solitudine. Io tendenzialmente faccio fatica a decidere. Questo è per me il peso più grande. Vorrei condividere tutto, a volte però viene il momento della responsabilità. E allora la difficoltà più grande io la percepisco in questo: è legata alla solitudine del ruolo dell’episcopato, il peso. Il fatto che alla fine in alcune situazioni non puoi sottrarti al dover decidere. Faccio fatica perché io dubito sempre delle mie decisioni. L’altra difficoltà è l’effetto del ruolo: io vorrei scomparire. È un peso essere sempre al centro dell’attenzione. Mi piacerebbe tanto poter entrare e starmene in fondo alla sala, senza comparire, senza dover dire sempre una parola».