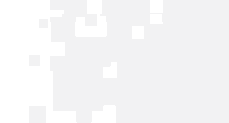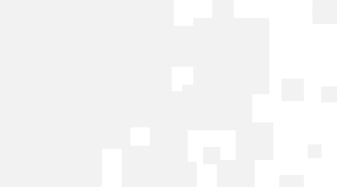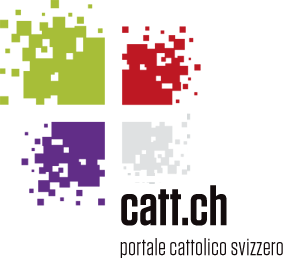Lo psicoterapeuta Nicola Gianinazzi su raduni giovanili e pandemia
La voglia di ritrovarsi è tanta, complice anche la bella stagione e il desiderio di incontrarsi dopo il lockdown. Se il comportamento di tanti giovani è esemplare, tuttavia alcuni assembramenti giovanili spontanei preoccupano. Pensiamo allo scorso fine settimana alla Foce del Cassarate, a Lugano. Ne parliamo con Nicola Gianinazzi membro di comitato dell’Associazione svizzera delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti.
Nicola Gianinazzi, come motivare i giovani, in queste belle serate estive a ritrovarsi rispettando le misure di sicurezza? «Questione molto complessa: da un lato c’è un’emergenza che chiede una risposta urgente e sanitaria solidale, dall’altra una ricerca di «sicurezza assoluta» che non possiamo più né pensare, né tantomeno sperare. L’approccio – a mio avviso – dovrebbe essere molteplice: comprendere che i giovani comunque, dopo tanti mesi, possono e devono aver voglia di vivere, incontrarsi e condividere. D’altro canto, tocca allo Stato mettere regole chiare e credo lo stia facendo, accettando anche di aver sbagliato e di dover correggere il tiro. Quindi limitare gli assembramenti e modulare l’utilizzo delle mascherine – come si sta facendo – può aiutare a dare un contenitore ai desideri dei più giovani. Vanno sostenuti in questo, perché non è proprio facile astenersi da tante cose pur non essendo malati e non vedendone gli effetti nell’immediato ».
Riguardo agli assembramenti spontanei, sui social si incontrano stigmatizzazioni di gruppi etnici… «Credo sia importante evitare il più possibile di alimentare sia la conflittualità tra generazioni come tra etnie: controllare tutto e tutti non è possibile, ma si deve informare, ascoltare e motivare con regole chiare; leggendo la realtà per quello che è, e questo è possibile. Si tratta in fondo di educazione personale che richiede tempo, come è stato per l’AIDS e per l’ambiente in questi anni».
In America ci sono gruppi di giovani che danno vita a party Covid-19 dove gli infettati entrano deliberatamente in contatto con coetanei sani, disposti a farsi contagiare. Che senso della vita, del pericolo e del prossimo c’è dietro a queste scelte? «Credo che questi ragazzi americani cerchino piuttosto – con una fuga in avanti – di scaricare l’ansia eccessiva dell’attesa di un eventuale contagio e del suo decorso: non tanto per mettere a rischio la propria vita, ma piuttosto – scegliendo una scorciatoia tipica in adolescenza – per risolvere il problema. Anche se poi evidentemente rischiano di contagiare altre persone più a rischio: un circolo vizioso. Pazientare, contenersi, aspettare tempi lunghi con prospettive incerte non sono risorse mentali particolarmente di moda».
«Il coronavirus non c’è più», ho sentito dire nelle scorse settimane. Perché si fatica ad accettare la realtà? «Forse si comunica ancora un po’ troppo cedendo alla tentazione di prevedere il futuro mentre di questo virus – mi dicono diversi amici scienziati – non conosciamo quasi nulla. I mass media poi fanno il resto, ma proprio perché questa richiesta di sicurezza e rassicurazione è enorme e la pressione si fa sentire».
L’idea di avere concretamente a che fare con il «prossimo» può favorire un discorso di responsabilità sociale? «Sono assolutamente certo che questa crisi sanitaria ci propone un’opportunità di crescita personale nel senso dell’empatia e della comprensione dell’altro-in-cui-mi-vedo (neuroni specchio o «doubling») e quindi dell’altro che da estraneo-lontano si fa prossimo. L’errore sta nel pensare che questo possa succedere come per incanto ovunque, per tutti e in breve tempo: restiamo pur sempre umani e liberi, anche di trasgredire queste regole sanitarie tanto ragionevoli e comprensibili. Eppure l’essere umano si educa perché si motivi liberamente, la pura coercizione o necessità non gli bastano mai per tenere sul lungo periodo e nei grandi gruppi».
Cristina Vonzun