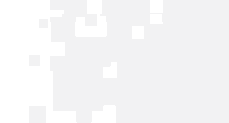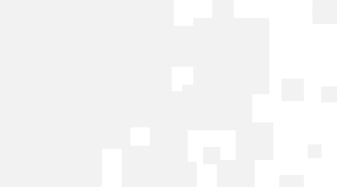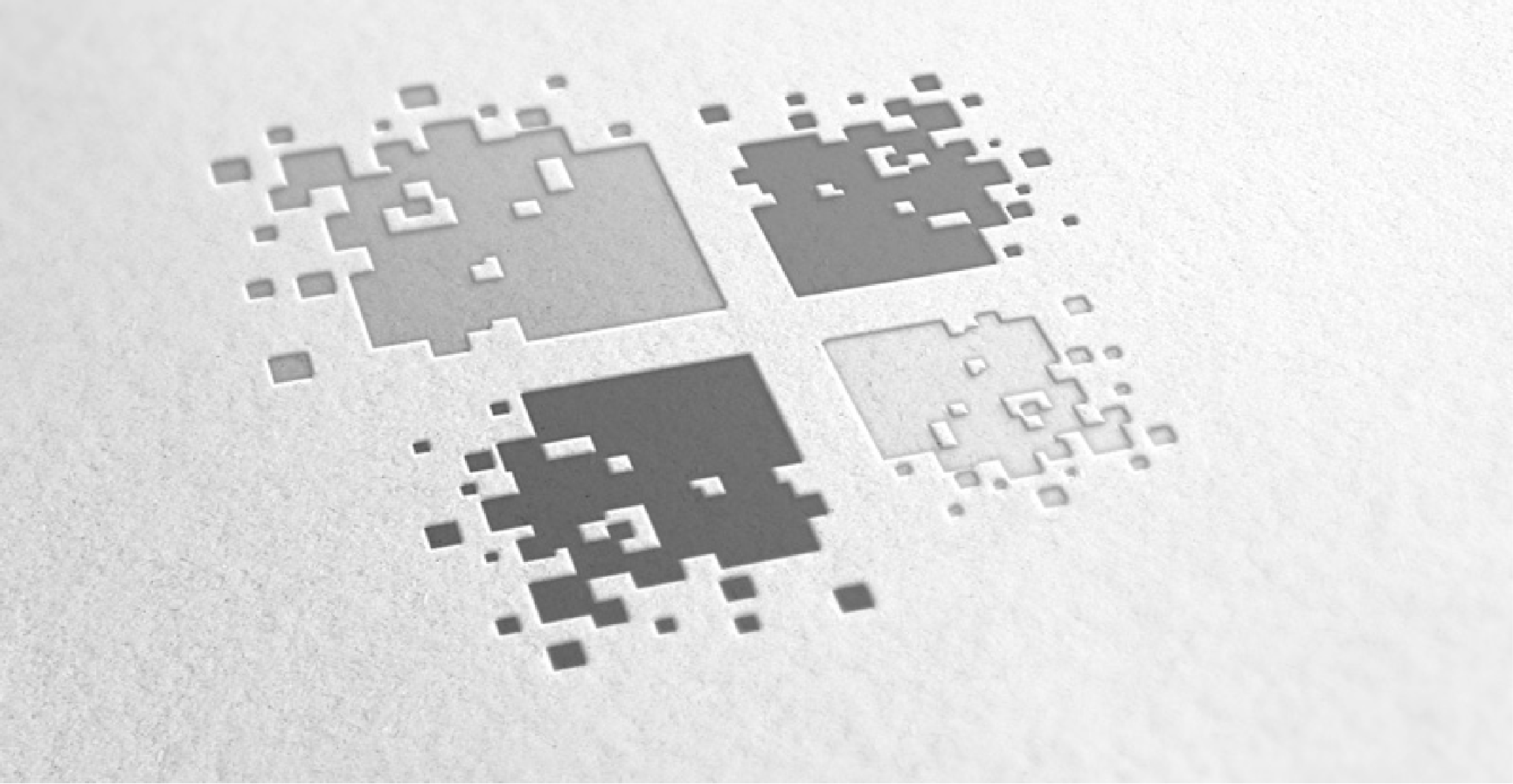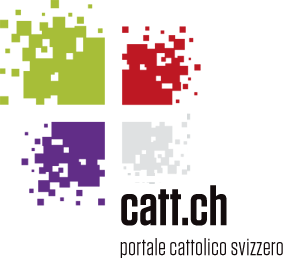Il sogno dei profughi siriani: tornare a casa
A guardarla dal campo profughi di Tel Abbas, nell’Akkar, l’estremo lembo nord del Libano, la Siria appare come un luogo intangibile, un’entità leggendaria, frutto di un lontano ricordo ormai sfumato e sbiadito. Eppure dista solo 4 km. Dal tetto di una casa sbilenca, incompiuta e pericolante, occupata da una famiglia di Homs e prospiciente l’accampamento dove trovano rifugio dal 2012 una ventina di nuclei familiari siriani, si vede bene. «Sono qui con la mia famiglia dal 2015 – spiega Abdulkadir un uomo sulla cinquantina giunto nel momento in cui la guerra infieriva senza tregua su Aleppo, con i suoi nove figli e la moglie – abbiamo ancora il terrore negli occhi e nelle orecchie, i bambini sognano spesso il suono delle bombe». Ma la speranza di un futuro diverso, in queste tende tanto dignitose quanto fatiscenti, in mezzo al nulla dell’ultima propaggine del Paese dei cedri, sembra ormai ridotta al minimo. «Sogno di riprendere a studiare – dice uno dei figli, il diciannovenne Ahmed – non ricordo più come si scrive». Purtroppo non rammenta più neanche come si gioca, come si trascorre il tempo spensierati e liberi, alla maniera degli adolescenti.
È questo forse uno degli aspetti più drammatici dell’esodo di milioni di persone dalla Siria in guerra. L’adolescenza di centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze, cresciuti prima sotto le bombe e poi nei campi profughi in Libano, in Giordania o Turchia, è stata per sempre spezzata. C’è un’intera generazione di giovani siriani che sta crescendo senza istruzione e sviluppando una preoccupante attitudine alla rassegnazione dopo aver visto attorno a sé quasi esclusivamente violenza estrema e il degrado dei campi. «Di giorno lavoro come muratore o nella raccolta delle patate – riprende Ahmed con un filo di voce e gli occhi bassi – e vengo pagato poco e saltuariamente».
Il Libano può essere tranquillamente identificato come il Paese dei profughi. Di recente è stato »festeggiato» il settantennale della presenza di rifugiati palestinesi giunti qui nel 1948 a seguito della creazione dello Stato di Israele. A loro si sono aggiunti quelli arrivati a varie ondate mai completamente sopite. Nella stragrande maggioranza sono ancora lì. Ma il grosso del fenomeno si è registrato dallo scoppio della crisi siriana. Le cifre di profughi giunti dal Paese vicino (ma anche dall’Iraq spinti dall’avanzata dell’Isis) variano da un minimo di un milione a un massimo di circa due. Per un Paese di 10 mila km quadrati con 4,5 milioni di abitanti e una grossa fetta di popolazione sotto la soglia di povertà, è davvero troppo.
Da quando, in Siria, la situazione ha cominciato a normalizzarsi e gli scontri a diminuire, lentamente i profughi provano a fare ritorno se non nelle proprie case – in gran parte distrutte – almeno nelle proprie zone. L’Unhcr parla di circa 500mila persone. La maggior parte di questi però, circa il 90%, erano sfollati interni. «Da questo campo e da altri con cui siamo in contatto – spiega Alessandro Ciquera coordinatore del progetto di Operazione Colomba (il Corpo nonviolento della Comunità Giovanni XXIII fondata da Don Benzi) a Tel Abbas – nessuno è tornato. Non basta che cessino i combattimenti – peraltro non ancora ultimati – per far tornare la gente. Molti degli uomini sfollati dalla Siria e dislocati nei campi, temono che se rientrassero verrebbero identificati con i ribelli o i disertori e sbattuti in carceri da cui difficilmente uscirebbero.
Alessandro è venuto qui due anni fa e non se ne è più andato. Assieme a un gruppo di ragazzi che si alternano ma garantiscono costantemente una presenza fissa, vive in una tenda al centro del campo, nelle stesse condizioni delle famiglie siriane. A differenza di altre organizzazioni presenti nell’area, loro condividono tutto con i profughi e scelgono di restargli accanto con il primario scopo di fornirgli sostegno morale e vicinanza. «La vita per loro è davvero dura. Molti portano i segni di ferite fisiche subite in Siria o durante il viaggio, tutti sono disperati perché non vedono un futuro diverso per sé e, sopratutto, per i figli. Noi li ascoltiamo, li seguiamo nelle difficoltà dei documenti, delle visite mediche, presentiamo istanze e siamo per loro una difesa in un contesto in cui l’integrazione è spesso difficilissima». Qualche mese fa, in piena notte, è stata data alle fiamme la scuola del campo dove i bambini facevano attività didattiche animate dai volontari.
Le vie di uscita, quindi, sono ridotte se non esaurite. Costruire una vita futura in Libano, senza documenti (il Libano non ha l’istituto dell’asilo e i profughi vivono de facto clandestinamente) e in un contesto di diffidenza, è quasi impossibile. Tornare, al momento, non sembra un’opzione. «Tutti – riprende Alessandro – sperano nei corridoi umanitari (da qui sono partite varie famiglie grazie all’iniziativa inaugurata da Tavola Valdese, Sant’Egidio e Federazione Chiese Protestanti) per giungere in Europa ed evitare di farlo attraverso i barconi. Ma sanno bene che ne potranno andare pochi».
Difficile intravedere segnali di speranza uscendo dal campo di Tel Abbas. Ad aprire uno spiraglio di fiducia provvedono i bambini più piccoli. Dal 2015 il Ministero dell’Educazione libanese, non riuscendo ad inserire l’enorme massa di minori giunti dalla Siria nelle classi frequentate dagli alunni libanesi (al momento si calcola che i siriani in età scolare siano 300mila in più di quelli libanesi), ha istituito un secondo turno pomeridiano per loro, per permettergli di completare almeno il ciclo elementare. Alle 14, guidati dai volontari di Operazione Colomba, in mezzo a un vociare finalmente allegro, i bimbi si mettono in fila, zaino in spalla, per andare a scuola. E tornare, per qualche ora, alla normalità.
Luca Attanasio – VaticanInsider