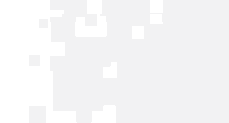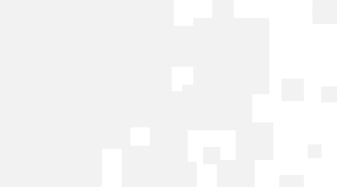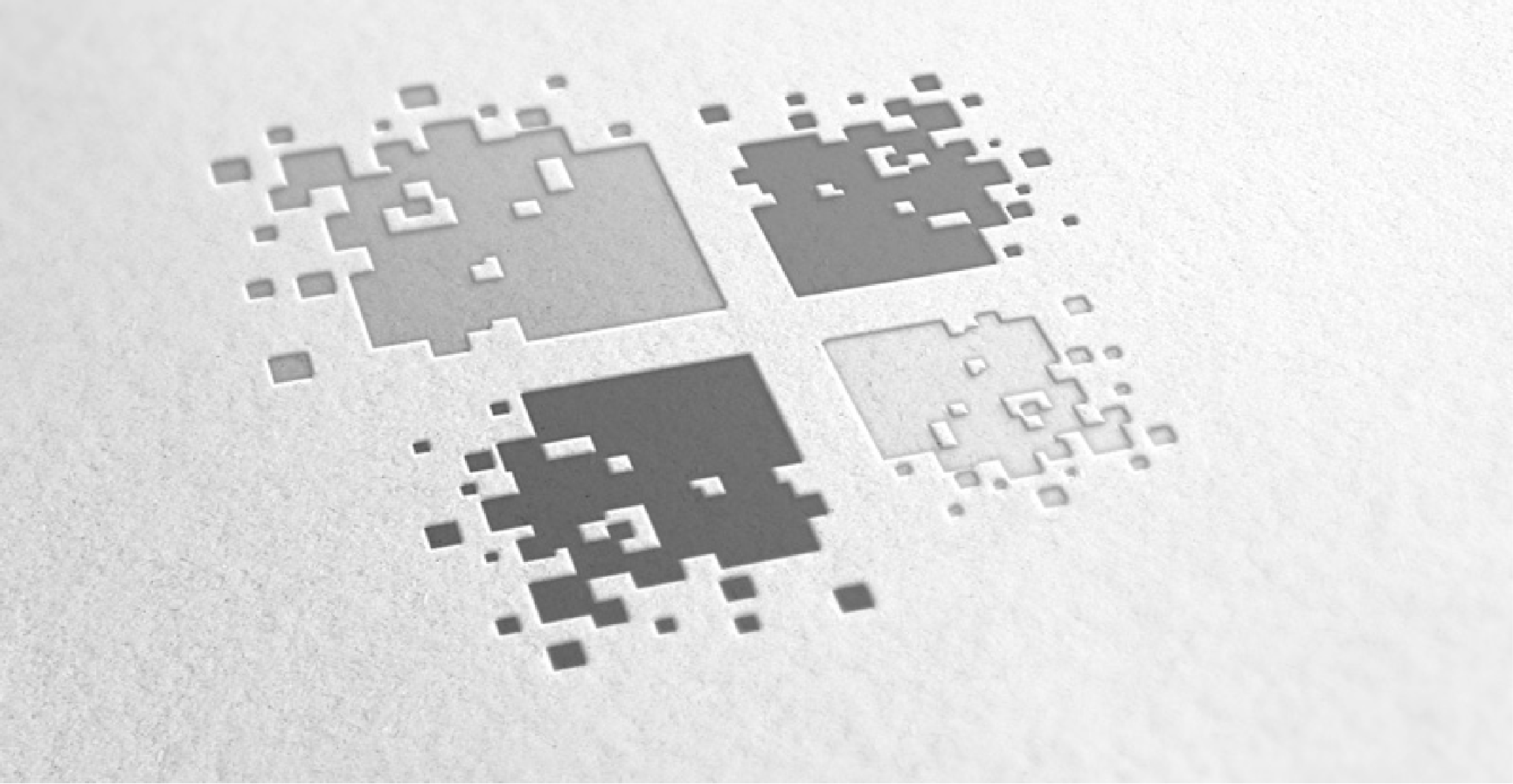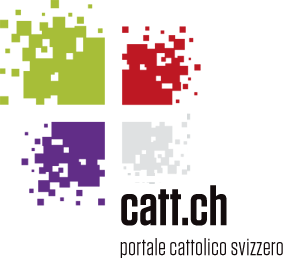Denuncia dell’Onu. Disumane le condizioni degli aborigeni
Si parla poco dell’Ungheria, ma il volume appena pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana nella collana del Pontificio Comitato di Scienze Storiche (n. 45) serve a ricordarci quante sofferenze e quanti rancori si celino in questo paese, sconvolto e sfigurato da ciascuna delle grandi tragedie della storia novecentesca: le due guerre mondiali, il nazismo e il comunismo: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l’Ungheria (1920-2015), a cura di András Fejérdy, 390 pagine, 28 euro.
Fino al 1918 il regno d’Ungheria — metà della duplice monarchia austro-ungarica — era una grande potenza europea, collocata proprio al centro dell’Europa ed estesa su 325 chilometri quadrati, più dell’Italia attuale. Andava da Fiume, sull’Adriatico, fino a Brasov, oggi nella Transilvania romena. La prima guerra mondiale distrusse questa fragile e poderosa costruzione — la mitica Cacania descritta da Robert Musil in una pagina indimenticabile de L’uomo senza qualità: «nazione incompresa e ormai scomparsa, che in tante cose fu un modello non abbastanza apprezzato» — provocando un cumulo di macerie che ancora gravano su di noi. L’Ungheria postbellica perdette due terzi dell’antico territorio e la popolazione fu ridotta da venti a sette milioni. Un trauma da cui il paese non si è mai ripreso e che continua a condizionarne la politica, come ribadisce anche in queste pagine il ministro degli esteri di Budapest Péter Szijjártó: «L’Ungheria non rinuncia mai, in nessun caso, neanche a uno solo dei suoi cittadini», dovunque si trovino.
La catastrofe seguita alla prima guerra mondiale è qui ben descritta da Márk A. Érszegi. Due terzi delle antiche terre della corona di santo Stefano — come si definiva l’Archiregnum Hungaricum — passarono agli stati successori: Romania, Austria, Cecoslovacchia, Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (poi di Iugoslavia). Diocesi smembrate, vescovi trattati improvvisamente da nemici, preti e fedeli senza più patria né identità. Molti si perdettero. Dovunque dilagarono nazionalismi sfrenati, privi di criterio e di misura.
A complicare il quadro si aggiungeva il problema della destinazione delle grandi proprietà ecclesiastiche. Il caos dilagante fu accresciuto dall’avvento della Repubblica dei Consigli, il tentativo rivoluzionario bolscevico guidato da Bela Kun che in Ungheria seminò il terrore per quattro mesi, dal 21 marzo all’inizio di agosto del 1919. A metà aprile del 1919 il nunzio Teodoro Valfrè di Bonzo, che da Vienna cercava di documentarsi su quanto accadeva a est, scriveva alla Santa Sede che «il regime bolscevico ha inaugurato colà il regno del terrore. Una piccola minoranza di delinquenti, che si è impadronita del potere e dispone della forza, tiranneggia a suo piacimento l’intera popolazione».
E riferisce che il vescovo di Szombathely, incarcerato a Budapest, gli aveva fatto giungere un biglietto disperato: Episcopus Sabariensis in maximo capitis periculo est. In nomine Domine afferte auxilium. Sappiamo che in quei mesi anche il futuro Primate Mindszenty patì il carcere. Quando l’intervento militare romeno determinò il crollo del governo bolscevico, emerse la figura dell’ammiraglio Miklós Horthy, che da Szeged aveva guidato l’opposizione e che fu eletto reggente dello stato nel 1920, non essendosi potuta risolvere la questione monarchica. Nell’Ungheria interbellica — paradossalmente una «monarchia senza re» — poterono dilagare perciò i più accesi sentimenti revisionisti dei trattati di pace, un irredentismo senza freni e una animosità non meno forte contro Stati Uniti e Francia, massimi responsabili della disfatta del vecchio regno ungarico. La Chiesa rimase uno dei pilastri del sistema. Quando fu aperta la nunziatura a Budapest, nel mese di ottobre del 1920, il nunzio ricevette un’accoglienza trionfale: «Così non è stato ricevuto nunzio in nessuna parte del mondo», si commentò compiaciuti, a Roma, in Segreteria di stato.
Tuttavia questa commistione di sacro e profano, che continuava molti aspetti del vecchio sistema asburgico della Chiesa di stato, trasformando i vescovi in «grandi signori» e il clero in un ceto impiegatizio (l’osservazione è del nunzio Angelo Rotta in un rapporto a Pacelli del 1935) non era più al passo con i tempi e non mancò di preoccupare fortemente Pio XI, che pure era ammirato dalla forza organizzativa e politica del cattolicesimo istituzionalizzato magiaro.
Non a caso mandò a Budapest a presenziare al congresso eucaristico internazionale, nel mese di maggio del 1938, il segretario di stato cardinale Pacelli. Ma dagli studi qui pubblicati si ricava che la difesa delle prerogative ecclesiastiche di fronte alle pretese statali (in materia di patronato, di nomine vescovili, di giuramento dei vescovi) fu sempre prioritaria, così come si ricava che fra gli stessi vescovi ungheresi non mancava chi, come il vescovo di Kaloksa Gyula Zichy, temeva negative conseguenze dall’infeudamento della Chiesa allo stato.
Poi vennero gli anni tragici della seconda guerra mondiale, quando l’irredentismo e il revisionismo ungheresi, che erano stati preponderanti per vent’anni, furono tutt’altro che estranei alla buona accoglienza ricevuta dai nazisti. Ma Budapest si caratterizzò anche per l’opera indefessa di aiuto agli ebrei compiuta dal nunzio Rotta e dal suo segretario Gennaro Verolino, qui ben descritte, che valsero loro il riconoscimento israeliano di Giusti fra le nazioni. Dopo la guerra, quando si impadronì del governo il comunismo sovietico, si scatenò in Ungheria una feroce lotta anticattolica, alla quale probabilmente non furono estranee le contiguità con il potere di Horty della Chiesa magiara prebellica. La lotta iniziò proprio con l’espulsione di Rotta e la chiusura della nunziatura, all’inizio di aprile del 1945, e culminò con la tragica odissea del primate József Mindszenty, condannato all’ergastolo nel 1948, liberato durante l’insurrezione del 1956 e poi rifugiato nell’ambasciata americana, dove visse rinchiuso, senza mai poterne uscire, fino al 1971, quando l’Ostpolitik di Agostino Casaroli, ottenne la sua uscita dall’Ungheria.
Su questa vicenda — uno dei capitoli fondamentali della storia di quegli anni — il libro dice meno di quanto vorremmo. Ma del caso Mindszenty si è parlato a lungo e con grande libertà nel corso del convegno su «Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia» svoltosi a Venezia nello scorso mese di ottobre a opera della Facoltà di diritto canonico San Pio X, della Facoltà di teologia dell’università Comenio di Bratislava e dello stesso Pontificio Comitato di scienze storiche. Gli atti sono in arrivo nella medesima collana del Pontificio Comitato, a cura di Emilia Hrabovec e Giuliano Brugnotto. Li attendiamo perciò con il massimo interesse.
(Osservatore Romano)