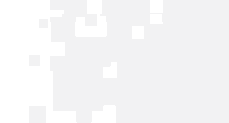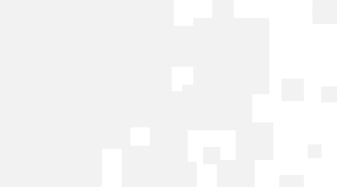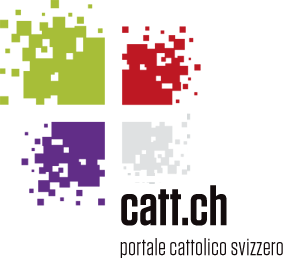A colloquio con il cardinale Sérgio da Rocha, arcivescovo di Brasília. Una Chiesa che conta sui poveri
La Chiesa in Brasile lavora da sempre con i poveri e conta su di loro. «Sono stati proprio i poveri a darmi la notizia della mia nomina cardinalizia» confida sorridendo Sérgio da Rocha, arcivescovo di Brasília e presidente della Conferenza episcopale brasiliana, al quale Papa Francesco ha conferito la porpora nel concistoro dello scorso 19 novembre. «Credo sia stato un segno» racconta in questa intervista all’Osservatore Romano, sottolineando che il Paese, con le sue disuguaglianze e contraddizioni ma anche con i valori e le grandi potenzialità, è un laboratorio per una Chiesa veramente in uscita che si mescola alla gente e va in cerca dei lontani.
Come ha accolto la nomina a cardinale?
Con sorpresa, gioia, senso di responsabilità e speranza. Stavo compiendo una visita pastorale e missionaria in una delle parrocchie più povere della capitale. Era domenica mattina presto, verso le sette, e mi trovavo in una di quelle che si chiamano «occupazioni», i luoghi che i poveri scelgono per sistemarsi non avendo dove abitare. Sono stati proprio i poveri a darmi la notizia. Credo sia stato un segno. All’inizio immaginavo si trattasse di un errore: pensavo che forse non avessero capito bene il Papa che parlava in italiano. Ma i poveri insistevano e mi dicevano che ero proprio io. Ricordo che questa notizia li ha resi molto contenti, perché attraverso di me si sentivano amati e valorizzati dal Pontefice che sceglieva un vescovo brasiliano. Da parte mia sono rimasto sorpreso della bontà di Francesco, che sempre ci stupisce con i suoi gesti di misericordia. Credo che la mia nomina sia stata proprio un segno ulteriore della misericordia di Dio e della bontà del Papa. Allo stesso tempo, sento il senso di responsabilità a collaborare più strettamente con il successore di Pietro, portando l’esperienza della Chiesa in Brasile.
Che significa essere vescovo di un’arcidiocesi come Brasília?
Il distretto federale di Brasília ha un valore che travalica i suoi confini e va considerato nel contesto di tutto il Brasile. È formato da gente di ogni parte del Paese. Fondata poco più di cinquant’anni fa, Brasília infatti è composta da diverse città unite per formare il distretto federale. Al suo interno vivono persone di culture e religioni diverse. La convivenza, lo stare insieme in modo fraterno e cordiale, è un valore da sottolineare nel mondo di oggi, dove c’è tanta difficoltà nei rapporti tra le culture. Se c’è una caratteristica di Brasília è proprio questa convivenza di gente proveniente da ogni parte del Paese: pochi dei suoi abitanti — solo i più giovani — sono nati nella città. In effetti, siamo tutti immigrati, me compreso. Purtroppo, esiste anche una disuguaglianza sociale. Con più di tre milioni di abitanti, vi sono zone molto ricche e altre poverissime. Proprio nella capitale federale c’è un grande divario tra enormi ricchezze e povertà estrema. Attualmente la più grande favela del Paese si trova a Brasília e non a Rio de Janeiro: si chiama «Sol nascente».
Cosa comporta questa multiculturalità?
La gente è molto aperta, cordiale, religiosa, ma deve affrontare immensi problemi economici e sociali. La disuguaglianza è un valore e una sfida molto grande per la Chiesa. Evangelizzare questi ambienti non è facile. Da una parte, riscontriamo una pietà popolare molto forte; dall’altra, un’indifferenza del mondo intellettuale e universitario, i moderni areopaghi del Brasile, che sono più lontani dalla Chiesa. Per noi è una sfida, perché dobbiamo occuparci di tutte queste realtà. Nel Paese questa situazione si verifica anche in altre zone, ma a Brasília è più marcata. Poi c’è il problema della formazione delle comunità e della costruzione di chiese. È difficile oggi realizzare edifici religiosi. Per farlo si deve acquistare il terreno dal Governo e i costi sono elevati. Tuttavia, sto cercando in ogni modo di impegnarmi in questa direzione, perché sono convinto che la comunità è una famiglia e, come tale, ha diritto a una casa e ha bisogno di una casa.
Qual è la sua esperienza di presidente della più grande conferenza episcopale del mondo?
La conferenza episcopale ha per scopo quello di fare comunione, di camminare insieme, soprattutto per quanto riguarda l’azione evangelizzatrice. La nostra si divide in diciotto conferenze regionali e ognuna ha una propria autonomia. Per questo, il fondamentale principio su cui ci basiamo è quello di organizzare la Conferenza nazionale rispettando le differenti regioni. Come in tutte le conferenze, un ruolo molto importante è svolto dal consiglio permanente e dal consiglio per la pastorale. Quando una volta all’anno si riunisce l’assemblea generale, siamo 460 vescovi. Solo gli emeriti sono circa 150. Certamente questa è una responsabilità per noi. La sfida è di prestare attenzione alle differenti situazioni regionali. Per esempio l’Amazzonia è un universo a sé rispetto alle altre aree del Paese. Il nord-est, dove sono stato undici anni vescovo — sei anni a Fortaleza e cinque a Teresina — è la zona più cattolica. Se guardiamo al sud-est, scopriamo che è l’area più sviluppata economicamente, con San Paolo e Rio de Janeiro. Alcuni dicono che il sud è più europeo, perché è significativa l’influenza della cultura italiana e tedesca. Il problema è: come unire tutte queste aree rispettando e valorizzando le diverse realtà? I vescovi dell’Amazzonia ci trasmettono delle esperienze, ma anche delle preoccupazioni che dobbiamo assumere comunitariamente. È una realtà che ci interpella, non possiamo lasciarli da soli. Il nord-est ha altre priorità: è la parte più povera, ma ci sono una cultura e una religiosità popolare molto marcate. Per valorizzare queste situazioni e unire tutti cerchiamo ogni anno direttive pastorali comuni a livello di conferenza episcopale.
Non manca quindi il lavoro.
In questo momento, nel secondo anno della mia presidenza, stiamo cercando di decentrare e valorizzare le regioni. Abbiamo avuto recentemente la riunione dei vescovi dell’Amazzonia e il prossimo incontro sarà per la prima volta con i presuli del nord-est. Questa è una risposta all’invito che Papa Francesco ci ha rivolto quando è venuto a Rio de Janeiro. Ha chiesto di decentralizzare e di valorizzare le regioni. Effettivamente, il Paese è grande e non si può concentrare tutto e vederlo solo attraverso gli occhi di Rio o di Brasília. La stampa in genere è portata a questo. Al momento ci occupiamo di evangelizzare l’Amazzonia, perché è difficile trovare missionari. Una volta erano i religiosi dell’Europa che si impegnavano in questa missione, adesso non più. Abbiamo bisogno di molti missionari e invece ce ne sono pochi. C’è poi il problema di come evangelizzare i poveri. C’è un dato molto interessante: coloro che si dichiarano senza religione non si trovano solo negli strati più alti o intellettuali della società, ma anche tra i più poveri: pur essendo più portati alla fede, spesso non trovano spazio nella comunità cattolica e nemmeno nelle nuove denominazioni religiose. Sono quello che noi chiamiamo il povo da rua. È gente che non si sente accolta. Un tempo la Chiesa sceglieva l’opzione per i poveri e questi rispondevano. Adesso invece non è più così. Ma la Chiesa deve sempre andare incontro a questa gente.
Quali passi state facendo in questa direzione?
A Natale pensavo di celebrare la festa con loro per strada, poi ho preferito invitarli nella cattedrale, che è un simbolo della città. Quando questi poveri entrano in chiesa, spesso si commuovono, perché nella vita quotidiana c’è sempre qualcuno che li confonde con i criminali. C’è un senso di paura e ciò non favorisce l’accoglienza. Esiste la pastorale del povo da rua che cerca di andare incontro ai poveri laddove vivono per offrire loro condizioni di esistenza migliori. Abbiamo delle case che mettiamo a disposizione di questa gente. D’altra parte, non possiamo dimenticarci del mondo universitario e intellettuale, che in grande parte si è allontanato dalla fede. In Brasile la secolarizzazione coinvolge in maggior parte gli studenti e gli intellettuali. C’è una pastorale specifica per loro e per il mondo della comunicazione. La questione è che il Paese è molto grande. Si organizza la pastorale, ma come coinvolgere tutti? Ci sono delle lacune nel nostro impegno: mi riferisco, per esempio, al mondo dello sport e dell’arte, che sono quasi dimenticati, come se non avessero bisogno del Vangelo e di Cristo. Spesso le nuove denominazioni evangeliche vanno loro incontro. Ma qui vorrei fare una precisazione. Noi dobbiamo compiere il nostro lavoro missionario non per andare dietro a queste denominazioni: non serve farsi concorrenza. Esse vanno per la loro strada e lodiamo Dio per chiunque annunci il Vangelo. Ma noi dobbiamo annunciarlo perché Gesù ci ha mandato a evangelizzare tutti, soprattutto coloro che non lo conoscono.
Come si realizza questa evangelizzazione?
Abbiamo tante iniziative. Con Aparecida è cresciuta la coscienza missionaria e il rinnovamento della Chiesa in Brasile ha ricevuto un impulso. Inoltre, con l’Evangelii gaudium il Papa ci ha aiutato tantissimo. La novità è il coinvolgimento dei missionari laici. A Brasília, nell’ultima visita che ho compiuto, c’erano trecento missionari laici. Sono preparati per queste visite pastorali, che cominciano il venerdì mattina e finiscono la domenica pomeriggio. Essi condividono le loro esperienze con la comunità. Di solito, quando si parla di laici che vanno in missione si pensa ai movimenti ecclesiali. È vero, c’è un contributo, un apporto molto grande da parte di queste realtà. Io parlo invece della gente che vive nelle comunità parrocchiali, dove ci sono appartenenti ai movimenti ma anche laici che non ne fanno parte. Questo è interessante, perché la novità è coinvolgere tutti e non un solo gruppo: il rischio è che a volte si può creare una sorta di élite missionaria.
Che cosa può dirci in particolare sulla missione continentale?
C’è un segno particolare della missione continentale. La chiamiamo capelinha missionária (cappellina missionaria) ed è sempre affiancata dalla Bibbia. Questa capelinha viene ricevuta all’inizio della visita e poi passa da una parrocchia all’altra. Certamente, l’organizzazione pratica è molto diversa in tutto il Paese e nemmeno si parla sempre di missione continentale, ma lo spirito e la missione come tale è nel cuore della Chiesa. Dobbiamo crescere sempre più nella condivisione comunitaria della missione, per riconoscere che il soggetto di questo impegno non è solo un gruppetto ma l’intera comunità parrocchiale. Un aspetto su cui vorrei far riflettere è che quando si compie attività missionaria si scoprono delle realtà che non hanno attenzione da parte della Chiesa. Troviamo delle situazioni nel territorio della comunità che a volte nemmeno il parroco conosce, dato che le città crescono in fretta. Allora si comincia a costruire la comunità a partire dalla missione. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che la missione continentale non si può comprendere solo come un’iniziativa o una visita episodica. Queste sono uno strumento, ma quello che si desidera veramente è coinvolgere tutta la comunità e tutte le istanze pastorali affinché siano missionarie, cioè guardino oltre per andare fuori dalla Chiesa, dal gruppo che si raduna. C’è il rischio di sentirsi felici perché si sta bene insieme, come se alcuni fossero «beati» e altri no. La missione continentale ci ha aiutato a evitare questo. È interessante che la gente colleghi le visite missionarie al concetto di Chiesa in uscita. Le persone ringraziano il Papa perché è lui che ci ha mandato. Penso che questa apertura rinnovi anche il clero, perché quando finisce un’esperienza di missione i sacerdoti sono più motivati. Chi parte in primo luogo fa bene a se stesso, e fa bene anche al vescovo. Per conoscere la gente non si può guardare da lontano o dalla finestra della canonica, bisogna scendere per strada ed entrare nelle case. Abbiamo bisogno di andare incontro alle persone dove vivono, di stare con loro, di sentire le loro sofferenze e le gioie. La missione continentale ci ha aiutato molto in questo ed è servita a condividere la gioia del Vangelo. Ecco quello che il Papa ci spinge a fare.
Cosa è rimasto della teologia della liberazione nella Chiesa in Brasile?
Ci sono ancora molti valori: tra questi, un’attenzione più grande ai poveri, più solidarietà, più servizio agli ultimi. Soprattutto è rimasto il riconoscimento di valori e di esperienze, perché a volte si corre il rischio di ridurre i poveri a un problema. Al contrario, è stato compiuto uno sforzo per riconoscere i poveri come soggetto dell’azione. Si è cercato anche di organizzare un po’ più la comunità. Quello che la pastorale sociale oggi fa con motivazioni diverse, già in qualche modo è stato portato avanti a quei tempi, in quegli ambiti dove l’evangelizzazione è stata più esplicita. Certo, bisognerebbe parlare al plurale: non c’è stata un’unica teologia della liberazione. E non tutta la comunità ecclesiale in Brasile o la gente conosceva questa teologia. D’altronde, la Chiesa lavora da sempre con i poveri e conta su di loro. Non è un aspetto che è stato scoperto con la teologia della liberazione. Questa, però, lo ha sviluppato con una modalità e con un accento particolari. Nelle organizzazioni popolari ancora ci sono contributi che provengono da quell’esperienza, anche se non c’è sempre un rapporto diretto e automatico con quella teologia. Tuttavia, credo che il riferimento al Vangelo e a Gesù non possa mai mancare. Il modo di tradurlo ai nostri giorni si deve ricercare con una teologia che ha il suo valore e il suo ruolo specifico. Non si deve dimenticare che abbiamo bisogno dei teologi, non tanto per la vita quotidiana, ma per approfondire le questioni pastorali, perché altrimenti manca il fondamento e quel che resta è soltanto pratica.
(Nicola Gori/L’Osservatore Romano)