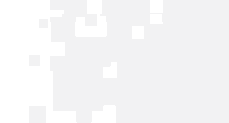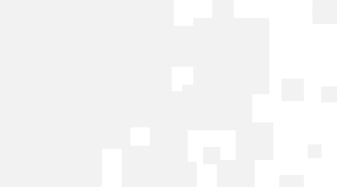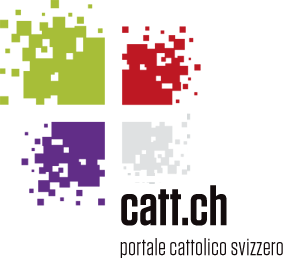II puntata – Verso il sinodo dei vescovi sulla famiglia: dalla Bibbia alla vita di oggi
di Ernesto Borghi
Dopo aver esaminato i caratteri fondamentali delle relazioni tra donne e uomini secondo quanto proposto da Genesi 1-2, veniamo a considerare, in questo secondo contributo, quali siano gli assi portanti dei rapporti interpersonali nel quadro della relazione tra Dio e l’essere umano. Lo facciamo esaminando il passo di Esodo 20 (con il parallelo di Deuteronomio 5) da cui sono tratti da sempre i cosiddetti «dieci comandamenti», troppo spesso ritenuti delle regole da applicare come un codice di leggi, quando sono ben altro. Cercheremo di comprendere gli elementi basilari di questi passi primo-testamentari e opereremo dei confronti tra di loro[1].
- I testi
«[1] Dio allora pronunciò tutte queste parole: [2] «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù. [3] non avrai altri dei di fronte a me. [4] Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. [5] Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio ardentemente appassionato, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, [6] ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. [7] Non pronuncerai senza ragione valida il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome abusivamente. [8] Ricordati del giorno di sabato così da santificarlo: [9] sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; [10] ma il settimo giorno è il sabato per il Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. [11] Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.
[12] Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio. 13] Non dovrai mai uccidere illegalmente. [14] Non dovrai mai commettere adulterio. [15] Non dovrai mai sequestrare. [16] Non dovrai mai pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. [17] Non dovrai mai desiderare la casa del tuo prossimo. Non dovrai mai desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo»»[2].
- Lettura dei testi
Analizziamo ora il brano del libro dell’Esodo relativo alle dieci parole, facendo successivamente dei confronti con il parallelo in Dt 5.
Il testo inizia così: «[1] Dio allora pronunciò tutte queste parole: [2] «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù»».
Il Signore si presenta ancora una volta senza manifestazioni particolari. La storia recente parla per lui ed è una storia di relazione con gli esseri umani del tutto positiva per loro: «se Dio ordina qualcosa agli israeliti, lo fa solo perché lui stesso per primo ha dato loro gratuitamente ciò che vi è di più essenziale, la libertà; d’altro canto si può supporre che egli non esigerà se non ciò che è in funzione di questa stessa libertà e contribuisce alla sua piena attuazione» (A. Fanuli, p. 492)[3].
Dopo questa introduzione il testo presenta undici affermazioni imperative, ridotte per tradizione a dieci (cfr. Dt 4,13), a seconda che si unifichino le prime due (come avviene nella tradizione cristiana) o le ultime due (come succede per la tradizione giudaica). Come vedremo, esse sono, in un certo senso, la spiegazione, lo svolgimento e il commento del v. 2 che abbiamo appena considerato. Il numero dieci ha importanza probabilmente a partire dal fatto che le dita di mani e piedi sono dieci, in una cultura come quella giudaica in cui il dodici è sinonimo di compiutezza.
Secondo una serie di passi biblici (cfr. Es 31,18; 32,16; 34,1-28; Dt 4,13; 9,10) Mosè scrisse le leggi su un libro (o rotolo di pergamena), mentre il «decalogo» fu redatto da Dio stesso su due tavole di pietra, senza che si dica quali precetti siano collocati sull’una o sull’altra.
L’importanza radicale delle dieci parole per la vita e la religiosità ebraiche rispetto alle altre disposizioni normative contenute nei libri della Toràh è indicata anche da due dati di fatto: la collocazione del decalogo era all’interno dell’arca dell’alleanza, mentre il libro delle altre disposizioni era a fianco dell’arca (cfr. Dt 10,1-4); la definizione delle affermazioni del decalogo non come comandamenti, ma devarim (= parole) ossia come elementi della diretta rivelazione divina (cfr. Es 34,28; Dt 4,13; 10,14).
La forma esortativa delle formulazioni e delle differenziazioni che si notano confrontando Es 20 e Dt 5 sembrano suggerire che il culto di Israele costituisse «il contesto vitale primario per i comandamenti. La loro raccolta in questa forma semplice, diretta, facile da memorizzare, tuttavia, stimolava la loro applicazione al di fuori del santuario e li manteneva vivi nella comunità»[4].
Vi è poi una differenza significativa tra le indicazioni positive e quelle negative. Nelle prime si riscontra l’uso di un modo verbale imperativo tout court, nelle seconde risalta il tempo verbale che con formulazione indoeuropea si definisce «imperfetto» e che indica, comunque, un’azione che non è compiuta, dal presente al futuro.
La prima opzione vincola in modo definitivo e puntuale, senza margine alcuno di movimento diverso per il destinatario.
La seconda, invece, implica non soltanto la necessità di non intraprendere un determinato comportamento, ma estende il concetto ad una logica di discernimento etico più profonda e coinvolgente.
Sarebbe come dire a coloro a cui il testo si rivolge: «Quando ti si presenterà questa possibilità, desidero che tu non compia tali azioni e spero, davvero, che non lo farai», in una prospettiva che lascia aperta la possibilità di scegliere assai più di quanto avvenga per le prescrizioni imperative dirette.
«»[3] non avrai altri dei di fronte a me»». L’esclusivismo del rapporto che gli israeliti hanno accettato non tollera deroghe di sorta. Se la loro vita sussiste soltanto grazie all’esistere e all’agire divini, essa deve essere finalizzata a Dio senza digressioni e distrazioni. E la liberazione che il Signore ha operato a favore degli esseri umani, sarà attuata completamente, se e quando essi si lasceranno coinvolgere. «Con l’accettazione del primo comandamento Israele compie la sua opzione di fondo e la traduce nel dialogo continuato dell’ascolto e della realizzazione delle altre parole»[5]. Questo primo comandamento è – come si vedrà poi – quello che conferisce senso e ragion d’essere a quelli successivi.
««[4] Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra»».
Nell’antichità mediorientale ogni immagine era reputata una forma importante della presenza dell’entità rappresentata. Nel caso delle divinità ciò significava pensare di poter catturare la potenza divina, utilizzandola a proprio uso e consumo. Il Dio dei padri d’Israele non può essere raffigurato attraverso alcun accostamento con esseri discendenti dalla sua azione creativa, perché nessuno potrebbe rappresentarlo in modo adeguato.
E nel momento in cui l’unica immagine «autorizzata» del divino è quella costituita dall’umanità fatta di maschi e femmine, qualsiasi altra rappresentazione è idolatrica. Essa induce, quindi, ad una religiosità deteriore, cioè tragicamente pagana, come gli stessi israeliti ebbero modo di sperimentare più avanti, con il famoso vitello d’oro (cfr. Es 32,1-6): il Signore Dio «resta al di sopra dell’universo opera delle sue mani… Egli è il Dio trascendente e pertanto il culto deve rispettare questa sua proprietà. Il divieto di raffigurarlo era un mezzo per sottolinearla»[6].
Comunque, anche in presenza di effigi divine già realizzate, l’atteggiamento di chi ha accettato di entrare in alleanza con il Dio liberatore dall’Egitto deve essere sempre lo stesso: «»[5] Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai»». Si esclude, pertanto, qualsiasi possibilità di adorazione o anche di minima attenzione che non riguardi il Signore. E tutto ciò perché la relazione offerta e accettata – come e più dei trattati di vassallaggio politico a cui è, in varia misura, accostabile – sottopone i contraenti a conseguenze precise quando si sottraggono a quanto hanno liberamente stipulato. L’apparente innocenza dell’idolatria è, in realtà un tranello (Dt 7,16) che contiene in sé radici mortalmente tossiche (Dt 29,18)[7].
«»Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio ardentemente appassionato, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, [6] ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi»».
La gelosia di Dio è ben altro che il sentimento analogo proprio degli esseri umani: non vi è meschinità di alcun genere, ma soltanto il risentimento di chi viene tradito nella fiducia riposta nei partner.
Questa condizione colpisce[8] al massimo tutti coloro che siano ostili e possono contemporaneamente convivere in una famiglia patriarcale (quattro generazioni, dal padre al pronipote).
L’amore di benevolenza nei confronti di quanti sono fedeli alla relazione accettata è, invece, senza limite. Secondo alcuni studiosi[9] il perseguire la colpa si deve intendere nel senso che il Signore Dio verifica se le generazioni successive ripresentano le stesse infedeltà dei loro ascendenti. Tuttavia, anche in questa interpretazione più circoscritta, per una mentalità moderna appare assolutamente ingiusto che la responsabilità di alcuni possa coinvolgere, nelle sue conseguenze negative, altri che ne sono estranei, solo per il fatto di essere i discendenti diretti dei colpevoli.
Il mondo biblico antico pre-profetico aveva però altri parametri: dominante era il concetto della «personalità corporativa», cioè della solidarietà profonda tra tutti gli esseri umani, in particolare quelli con legami di sangue o, comunque, familiari. Solo profeti come Ezechiele (cfr. cap. 18) e Geremia (cfr. 31,30) o gli autori di Deuteronomio (cfr. Dt 24,16) preciseranno la nozione di responsabilità individuale senza ripercussioni sulle generazioni successive.
D’altra parte l’enorme sproporzione tra punizione e beneficio fa comprendere quanto il Signore Dio sia al di fuori da qualsiasi logica religiosa di ordine meramente retribuzionista. Qui si tratta di un Dio che si appassiona in profondità alla condizione degli esseri umani, è impegnato a conservare la serietà del rapporto con loro.
Si può parlare, insomma, dell’ira di Dio come della «tristezza del suo amore» di fronte alle sfrontate infedeltà dei suoi interlocutori umani. D’altronde si conferma senza equivoci la sua munificenza nel proporre un’alleanza che è anzitutto un dono e un’offerta libera[10].
«Il castigo è attribuito a Dio in senso metaforico: in realtà, chi si ribella a lui cade inevitabilmente nella trasgressione di tutti gli altri comandamenti che riguardano la giustizia sociale e priva gli altri (e di riflesso se stesso) del bene più grande cioè della libertà che Dio ha conferito al suo popolo. Il male da lui provocato è considerato come castigo divino in quanto è Dio che lo permette: se così non facesse, Dio toglierebbe all’essere umano ogni responsabilità, diventando egli stesso connivente con il suo peccato»[11].
A partire da questa calorosa ed intensa relazionalità, contrassegnata da una fedeltà che non ammette indebolimenti e distrazioni di sorta, prendono corpo gli altri principi etici. Essi hanno tutti una valenza di ordine sociale, dalla riaffermazione della serietà del rapporto con Dio a quella di ogni legame con gli altri viventi, anzitutto umani: «il Dio che dà tutto, pretende tutto. Lui non si accontenta di qualcosa»[12].
«»[7] Non pronuncerai senza ragione valida il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome abusivamente»»[13]. Si è già detto che il nome, per la cultura antica e, in specifico, biblica, racchiude in sé l’identità della persona non soltanto sotto il profilo «anagrafico», ma in termini di potenzialità globali: «ogni mancanza di riguardo al nome è riferita alla persona e alla sua dignità»[14].
Citare il nome divino è evocare la relazione con lui. Quindi la serietà responsabile di questo rapporto implica che, sin dal suo «inizio», tutto proceda in modo coerente. Né un falso giuramento né qualsiasi altra strumentalizzazione magica o pseudo-religiosa sono accettabili (cfr. Es 22,17; Dt 18,10-11).
La gravità della punizione è certo significativa. Infatti il verbo che si traduce con lasciare impunito viene abbastanza costantemente usato in casi di delitti rilevanti: adulterio (cfr. Pr 6,29); falsa testimonianza (Pr 19,5.9); omicidio (2Sam 14,9); violenza nei confronti dei poveri e blasfemia (Pr 17,5); arroganza nei confronti di Dio (Pr 16,5); giuramenti (Gen 24,8.41)[15].
«»[8] Ricordati del giorno di sabato così da santificarlo: [9] sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; [10] ma il settimo giorno è il sabato per il Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. [11] Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro»».
Una ragione umanitaria e una di carattere religioso motivano questo invito. Vi è il riposo psico-fisico necessario. Ma vi è anche il rispetto della conclusione della creazione. La dimensione memoriale costituisce il cuore del discorso.
Si tratta non soltanto di far ritornare alla mente tale riposo, ma di renderlo presente e vivificarlo in modo da mandarlo realmente ad effetto. Il tutto per riaffermare la dignità dell’essere umano e garantire «a ciascuno, almeno in minima parte, quella libertà che Dio ha dato a tutto il popolo. Per la tradizione sacerdotale (Es 31,13-17) il riposo in giorno di sabato è il segno dell’alleanza, il mezzo per eccellenza con cui gli israeliti si appropriano della santità di Dio»[16]. La lettura di questi versetti di Esodo privilegia la dimensione religiosa sino all’affermazione conclusiva.
In Dt 5[17]prevalgono, invece, le dimensioni umanitaria e storico-politica rispetto a quella religiosa. Il fatto che di sabato anche schiavi e schiave possano riposare come il loro padrone, significa consentire loro di essere, perlomeno un giorno alla settimana, al suo stesso livello, cioè degli esseri umani liberi.
E sottolineare la possibilità di «liberazione» settimanale degli schiavi, raccordandola alla memoria dell’esodo dall’Egitto, vuol dire essere spinti a realizzare questa liberazione per chi schiavo è ancora. Israele «osserva» il sabato, liberando se stesso e gli altri dall’asservimento al lavoro. Il sabato diviene l’esodo settimanale.
Il motivo della schiavitù in Egitto trattata nel testo deuteronomico può forse far pensare alla maggiore antichità di esso rispetto a quello di Esodo 20.
«»[12] Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio»»[18].
L’onorare i genitori proposto da questo comandamento consiste in questo: «glorificare» i genitori, ossia dare loro il giusto ed oggettivo valore[19], senza distinzione tra genitore e genitrice, in un quadro come quello della famiglia patriarcale semitica, in cui convivevano varie generazioni nella stessa casa.
La fedeltà, piena di rispetto, nei confronti dei propri ascendenti costituisce la condizione fondamentale perché le benedizioni connesse con l’alleanza si possano realizzare. In una cultura e società in cui l’autorità paterna si estendeva sino alla possibilità di vendere come schiavo il proprio figlio (cfr. Es 21,7; Ne 5,5: Dt 21,18-21) «»onorare» i genitori significa valutarli per quello che sono e che valgono, rispettarne il ruolo dirigenziale… Dal momento in cui deriva dai suoi genitori, l’uomo dipende da loro, è loro soggetto e questo per tutto il tempo che i genitori restano a capo della famiglia… Ogni azione in contrario attenta alla natura stessa dell’essere del figlio in relazione all’essere del padre»[20].
Il testo di Dt 5,16 sottolinea, in particolare, il collegamento conseguenziale tra l’onore ai genitori e due aspetti importanti: le possibilità di una lunga vita per il figlio che si comporta in questo modo[21] e di una convivenza positiva, per qualità ed estensione, a vantaggio di tutti, genitori e figlio, nella terra donata da Dio.
Resta comunque del tutto chiaro l’equilibrio di fondo che il comandamento intende promuovere e difendere: «glorificare il padre e la madre equivale a celebrare il dono della vita la cui trasmissione costituisce la peculiarità di ogni essere vivente. Esiste quindi una perfetta simmetria fra la glorificazione del padre e della madre, la lode del Creatore e la celebrazione della vita»[22].
«»[13] Non ucciderai illegalmente»».
Il verbo ratsàh contempla l’uccisione sia volontaria che involontaria (cfr. Dt 4,41-42) di una persona innocente come anche l’esecuzione di una persona riconosciuta colpevole (cfr. Nm 35,30). Questo è l’agire che il precetto intende contrastare. In questo ambito non sono contemplate, invece, altre situazioni quali l’omicidio bellico, la vendetta di sangue, la pena di morte e il suicidio. Forse questo precetto è presentato più efficacemente in Es 21,12 e in Nm 35,20-21:
«ogni atto di violenza contro una persona determinato dall’odio, dall’ira, dal dolo, dall’inganno, dal vantaggio personale, in qualunque circostanza e con qualunque metodo, che potrebbe portare alla morte (anche se non c’era l’intenzione di uccidere). «Assassinare» non coglie a sufficienza questo significato della parola. Il più generico «uccidere» aiuta meglio la comunità di fede, forzando a continue riflessioni sul significato del comandamento e ricordando a tutti che nel togliere la vita a un altro per qualunque motivo si agisce al posto di Dio… La motivazione profonda del comandamento è che la vita appartiene a Dio (Lv 17,11; Gen 9,6). L’intenzione divina nella creazione è che nessuna vita sia tolta»[23].
Chi uccide involontariamente rientra, come si è detto, nella casistica di questo comandamento, ma risulta escluso da punizioni, se si rifugia in particolari città destinate a proteggere quanti si sono macchiati di queste colpe (cfr. Es 21,12-14; Dt 19,3; Nm 35,9-34; Gs 20,11a). Il rispetto della vita è la base della convivenza umana. Già l’alleanza con Noè aveva previsto il rifiuto dello spargimento di sangue umano, proprio perché solo il Signore Dio può disporre della vita e del sangue che ne è l’emblema più diretto (cfr. Gen 9,5-7[24])[25].
«»[14] Non commetterai adulterio»». Per adulterio si intende la relazione di un uomo con una donna fidanzata o sposata, comunque vincolata ad una promessa matrimoniale già pronunciata. Il fatto che un uomo, fidanzato o sposato, abbia una relazione con una donna ancora libera da vincoli, non costituisce adulterio, ma azione soggetta a una semplice sanzione pecuniaria (cfr. Dt 22,28-29).
La gravità dell’adulterio è di ordine sociale: esso mina alla base la famiglia del proprio prossimo. In quanto attentatore a questo equilibrio umano essenziale, l’uomo è soggetto alla pena di morte così come la sua partner che è, a sua volta, fedifraga (cfr. Dt 22,22)[26].
«»[15] Non ruberai»». Il sequestro di persona a scopo di schiavizzazione era l’originaria colpa contemplata da questo precetto (cfr. la forma apodittica di Es 21,16 e la forma casuistica di Dt 24,7). Ad essa corrispondeva l’irrogazione della pena di morte, mentre il furto in sé rientrava nel comandamento espresso dal v. 17. Il furto restava comunque un reato assai dannoso per la comunità. Secondo Es 22,13 chi era sorpreso in flagrante era passibile di pena capitale, mentre, in assenza di flagranza, veniva condannato ad un risarcimento materiale.
«»[16] Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo»». Si è nel quadro della prassi giudiziaria e si vuole colpire l’agire che protegge un colpevole attribuendo ad un innocente responsabilità non sue. «Secondo Dt 17,6-7 due o tre testimoni sono sufficienti per mandare a morte un imputato: in questo caso, però, i testimoni sono tenuti ad assumersene la responsabilità scagliando contro di lui, al momento dell’esecuzione, la prima pietra»[27].
Nel testo «parallelo» di Dt 5,16 si parla di testimonianza vana, quindi con ogni probabilità «del pettegolezzo, forma di condotta particolarmente distruttiva nell’ambito della comunità, ma difficile da captare e reprimere sul piano giuridico»[28].
«»[17] Non desidererai la casa del tuo prossimo»». Una brama di carattere materiale che conduce all’appropriazione indebita: tutto questo processo è reputato illecito e censurato.
«»Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo»». Tutto quello che costituisce la dotazione normale del contesto familiare altrui deve essere sottratto alla propria brama. Infatti il testo non si oppone alla legittimità e naturalità dei desideri, ma alla trasformazione di essi in cupidigia.
Si tratta del completamento di un rispetto che appare avvolgere tutto il brano in esame. Minacciare la tranquillità quotidiana del prossimo risulta, in ultima analisi, un’azione da evitare sin dal suo profilarsi nel proprio cuore.
In Dt 5,21 la donna è all’apice dei beni altrui da non desiderare avidamente e il verbo riferito a tale desiderio è diverso da quello utilizzato, subito dopo, per la brama verso altri beni a cominciare dalla casa del prossimo. Sono dati di fatto questi che indicano, per esempio, la maggiore evolutezza sociale di questo testo rispetto a quello del libro dell’Esodo[29]. D’altronde chi poteva rubare? In particolare proprio i potenti, come indicano vari passi primo-testamentari (cfr. 1Sam 8,11-17; 1Re 21,1-24; Nm 16,15; 1Sam 12,3; 2Sam 11; Is 5,8-10). Tra questi testi appaiono eloquenti anzitutto i casi di Davide che prevarica su Uria e di Acab che fa violenza a Nabot. «In conclusione il comandamento difende piuttosto i più deboli contro i più potenti»[30].
Questo comandamento risale comunque «alla radice di tutti gli attentati al volto umano, cioè al cuore dell’uomo. È il cuore infatti che dà impulsi alla mano per uccidere e rubare, che si nutre dell’occhio per desiderare e trasmette alla bocca testimonianze false. Il cuore è la fucina del desiderio (hamad), di una bramosia che tende a tradursi in una calcolata appropriazione di beni»[31].
E al termine della recensione di Es 20 delle dieci parole il timore di Dio compare (cfr. v. 18) in termini apparentemente non dissimili da quelli menzionati in 19,16. Il tremore del popolo non deve comparire soltanto quando Dio rivela la sua potenza, perché esso se ne faccia un’idea grandiosa. Esso deve riscontrarsi anche quando manifesta la sua volontà, espressa nelle dieci parole: «Israele deve prendere sul serio il suo Dio, deve cioè far «sue» quelle parole, perché sono parole che saggiano la sua fedeltà di «popolo di Jhwh» e sono parole che portano al bene e alla vita»[32].
- Linee di sintesi
Se si considerano i due brani di Es 20 e Dt 5 rispetto ai loro contesti, appare abbastanza evidente la maggiore antichità del testo deuteronomico, anche in ragione della sua collocazione assai più coerente. In altre parole nel Deuteronomio il decalogo si trova al proprio posto e contiene elementi che fanno pensare ad una recensione più antica dal punto di vista letterario, anche se sociologicamente più avanzata[33].
Comunque, al di là di qualsiasi considerazione di ordine storico o ermeneutico, le differenze tra i testi di Es 20 e di Dt 5 testimoniano che la redazione finale è stata piuttosto travagliata[34]. I testi di cui disponiamo presuppongono che la popolazione alla quale i testi stessi si indirizzano sia stanziale in un territorio (si veda, per esempio, la citazione del bue, animale dedito al lavoro agricolo, la menzione di un’attività lavorativa regolare e della schiavitù)[35].
L’asse portante della vita morale ebraica è questa serie di precetti che non hanno in sé nulla di formalistico, ma stabiliscono una scala di priorità molto importanti, in cui il discernimento libero di ogni essere umano costituisce il pendant imprescindibile della gratuita offerta divina:
«i comandamenti non pretendono di fissare una volta per tutte, in modo esauriente e definitivo, ciò che bisogna fare o evitare per far piacere al Signore Dio, ma piuttosto intendono delimitare un campo di azione nel quale ciascuno deve operare per il bene di tutti in modo responsabile, ma con la massima libertà e creatività. Il successivo «codice dell’alleanza» (cfr. Es 20,22-23,19) sembra restringere in parte questa libertà. Per questo è tanto più significativo il fatto che per il redattore finale la vera «carta dell’alleanza» non è il codice ma il decalogo, il solo a essere pronunziato direttamente da Dio»[36].
E in questo quadro appare di grandissimo interesse un fatto: il tono del decalogo è marcatamente universale, senza distinzioni di sorta tra classi e gruppi. Nessuno può reputarsi escluso dalla proposta di obbedire a tali indicazioni etiche e religiose: il decalogo fa perno sull’esperienza di un Dio creatore davanti al quale non vi sono privilegi[37]. E appare la condizione fondamentale della libertà dell’essere umano a partire da una provocazione forse non troppo provocatoria: la libertà può essere conservata e vissuta da tutti e per tutti se deriva dall’ascolto di una parola che viene dall’esterno dell’individuo e che non viene negoziata, ma obbedita[38] con tutto il discernimento necessario, epoca dopo epoca, da persona a persona.
E in Dt 6,4-9 – cioè pochi versetti dopo la formulazione del Decalogo in Dt 5 – l’invito rivolto anche lettrici e lettori del XXI secolo è di seguire, con le differenze del caso, quello rivolto anzitutto a tutti i figli del popolo ebraico da molti secoli: «»Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte»».
Si tratta di un ascolto esistenziale che è possibile, sia pure nel mutamento di epoca e di codice culturale, se vi sono principi di riferimento etico che superano ciascuno degli individui perché si rifanno a valori che trascendono le singole situazioni, ma all’interpretazione umanizzante di esse possono contribuire in modo decisivo. Il decalogo biblico è essenzialmente questo: una grande via di libertà, che è rivolta all’obbedienza non di bambini o di adolescenti travestiti da adulti, ma di adulti responsabili ed intelligenti. E questo vale tanto nei rapporti familiari quanto in qualsiasi relazione sociale, si sia o meno credenti ebrei o cristiani. Anche al sinodo dei vescovi cattolici del prossimo mese di ottobre di questa libertà nel cuore e nella mente ci sarà un bisogno vitale…per il bene di tutti.
[1] Circa l’importante e annosa discussione scientifica sulla redazione di questi due brani primo-testamentari rinvio, per una sintesi efficace, a titolo esemplificativo nel quadro di una bibliografia sterminata, al saggio di D. Tonelli, Il Decalogo. Uno sguardo retrospettivo, EDB, Bologna 2010, pp. 48-56.
[2] Nel corso dell’analisi successiva del testo riporterò quello parallelo di Deuteronomio 5,6-21 nei passi che sono diversi dal testo di Esodo che ho appena presentato.
[3] A. Sacchi, I libri storici, Paoline, Milano 2000, p. 150. «Chi ha liberato il suo popolo dall’Egitto, desidera a maggior ragione liberarlo dalle sue zavorre e dai suoi problemi personali. Nel donargli una legge, Dio ha voluto fare di uno schiavo, il soggetto del diritto» (R. Badenas, Legge di libertà. Il valore dei comandamenti nella teologia della grazia, tr. it., Edizioni ADV, Firenze 2004, p. 66).
[4] T.E. Fretheim, Esodo, Claudiana, Torino 2006, pp. 287-288.
[5] A. Fanuli, L’alleanza al Sinai (Es 19-40), in Il messaggio della salvezza. Pentateuco, storia deuteronomistica e cronista, a cura di A. Fanuli-A. Rolla, Elledici, Leumann [TO] 1977, p. 506. «Non si tratta di fare dei confronti assurdi oltre che inutili tra la mia miseria e la grandezza infinita di Dio, tra i miei difetti e le Sue perfezioni. Nell’adorazione io, invece, vengo letteralmente strappato a me stesso e condotto direttamente di fronte all’Altro. Per cui ciò che conta, ciò che merita attenzione, ciò che mi assorbe totalmente è il Tu di Dio. E io non voglio altro che quel Tu» (A. Pronzato, Ritorno ai dieci comandamenti, 1, Gribaudi, Milano 2002, p. 55).
[6] A. Fanuli, L’alleanza al Sinai (Es 19-40), p. 508. «Neppure le istanze religiose sono esenti da tale rischio. Quando il prestigio, l’organizzazione, la personalità o la gerarchia si interpongono tra l’essere umano e l’Essere supremo, stiamo costruendo una «immagine» che nasconde Dio, quindi incorriamo nel «delitto» di idolatria» (R. Badenas, Legge di libertà, p. 74).
[7] Cfr. A. Nepi, Le maschere e il volto. Il divieto dell’idolatria in Es 20,1-7, in «Parola Spirito e Vita» 46 (2/2002), 20. Il primo caso di infedeltà a questo precetto è certamente quello di Es 32, ossia la costruzione del vitello d’oro. Il peccato in questione ha varie sfaccettature (cfr. J.-L. Ska, Ricchezza e povertà nell’esperienza e la legislazione dell’Esodo, in Id., Il Libro sigillato e il Libro aperto, EDB, Bologna 2005, pp. 342-343): impone a Dio una determinata rappresentazione come segno della sua presenza, limitandone umanamente la libertà di rivelazione; esalta un valore tangibile (quello economico del materiale con cui il vitello è stato costruito) come valore supremo; Israele proietta in Dio la sua brama di sicurezza in ordine alla fertilità e alla prosecuzione delle proprie generazioni (il vitello, nel mondo antico, è, per molti culti, la divinità della fertilità e della fecondità).
[8] Il verbo pqd va inteso nel senso di un intervento divino che intende chiedere conto, in termini punitivi, di mancanze ed omissioni (cfr. oltre al parallelo del nostro testo in Dt 5,9 anche Es 32,34; Lv 18,25; Nm 14,18; Is 13,11; 26,21; Ger 5,9.29; 9,8; 23,2; 25,12; 36,31; Os 1,4; 2,15; 4,9; Am 3,2.14a).
[9] Cfr., per es., J. Scharbert, Esodo, Morcelliana, Brescia 2001, p. 106.
[10] In ordine all’immagine del Dio cosiddetto geloso poiché in Es 34.6-7 «Dio stesso riprende la medesima immagine alla luce dell’apostasia del vitello d’oro, questo testo in ultima analisi riveste carattere di provvisorietà… Qui Dio si rivela a sorpresa come un teologo sperimentale! Inoltre dà prova di non voler scrivere un manuale di dogmatica ortodossa: le tavole possono sempre essere spezzate e sostituite da nuove. Questa è un’illustrazione particolarmente rilevante della necessità della contestualizzazione nell’uso del testo per finalità esegetiche e teologiche» (T.E. Fretheim, Esodo, p. 294).
[11] A. Sacchi, I libri storici, p. 152. «Credo che Dio non sia «pensabile», cioè non sia da pensare. Dio è da vivere, da lodare, da invocare, da cercare, da confessare, da amare, ma non credo che sia da «pensare». Del resto anche nella Bibbia «conoscere Dio» non significa pensare Dio, ma significa «amare» Dio» (P. Ricca, Le dieci parole di Dio, Morcelliana, Brescia 1998, p. 58).
[12] A. Pronzato, Ritorno ai dieci comandamenti, 1, p. 52.
[13] L’espressione lashawe’, che si traduce comunemente con l’avverbio invano, in realtà presenta una valore meno neutro, a partire dal significato pregnante del sostantivo shaw’: «la legislazione (cfr. Es 22,17; Dt 18,10s) e la predicazione (Is 47,9; Ger 27,9; Sal 58,6; ecc.) dirette contro la magia e la divinazione pagana indicano in realtà che shaw’ in alcuni strati sociali dell’antico Israele può avere avuto il significato di «potere magico, magia»» (J.F.W. Sawyer, shaw’, in DTAT, II, Marietit, Torino 1982, col. 797). E se si leggono anche passi quali Is 5,18; Sal 41,7; Gb 11,11; Sal 26,4; 24,4; Gb 31,5, ove il vocabolo significa danno e magia, l’espressione in esame «potrebbe designare non solo la potenza magica, ma l’uso negativo di essa (»a danno, abusivamente»)» (ibidem).
[14] A. Fanuli, L’alleanza al Sinai (Es 19-40), p. 513.
[15] «Il nome di Dio non va compromesso. È questo il rischio che corrono soprattutto coloro che danno a vedere di avere molta familiarità con Dio» (A. Pronzato, Ritorno ai dieci comandamenti, 1, pp. 170-171).
[16] A. Sacchi, I libri storici, p. 154.
[17] Questo è il passo di Dt 5 (trad. C.E.I. [2008] – in corsivo le parti di testo difformi da quelle di Es 20): «»[12] Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio, ti ha comandato. [13] Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, [14] ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero, che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. [15] Ricordati che sei stato schiavo nella terra d’Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del sabato»».
[18] Dt 5: «[16] Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato perché si prolunghino i tuoi giorni ed essi possano vivere bene con te nella terra che il Signore tuo Dio ti dà».
[19] L’imperativo intensivo kabbed deriva dal verbo kbd, che significa letteralmente essere pesante, attribuire peso a qualcuno, dunque onorare, non nel senso dell’elevazione di una persona al di sopra delle altre, ma come riconoscimento del suo posto nella convivenza sociale: «Il fatto che nell’AT l’onore tra uomini non è meno frequente dell’onore tributato dall’uomo a Dio, indica già che questi due tipi di onore non debbono essere incompatibili tra loro. In determinati casi (per es. Es 20,12) l’onorare fra uomini è essenziale quanto l’onorare Dio» (C. Westermann, kbd, in DTAT, I, coll. 689-690).
[20] A. Fanuli, L’alleanza al Sinai (Es 19-40), p. 520.
[21] La traduzione greca dei Settanta accentua in positivo la condizione del figlio che rispetta attivamente i genitori: non soltanto i suoi giorni sono auspicabilmente prolungati, ma lo scopo dell’onorare i genitori è anche quello di una vita felice.
[22] A. Chouraqui, I Dieci Comandamenti, Mondadori, Milano 2001, p. 120. Questo e il comandamento precedente, quello relativo al riposo del sabato, sono gli unici formulati positivamente in un decalogo dove le proibizioni sono numerose: la voce «ricordati» invita a ricordare «periodicamente il Creatore, con gratitudine, perché in questo ambito è inutile proibire. Il vero rispetto può sorgere soltanto da un libero impulso della volontà» (R. Badenas, Legge di libertà, p. 75).
[23] T.E. Fretheim, Esodo, p. 300.
[24] Per avere modo di approfondire anche la lettura ebraico-rabbinica di questo passo cfr., per es., A. Contessa-R. Fontana, Noè secondo i rabbini, Effatà, Cantalupa (TO) 2007, pp. 68-72.
[25] Commentando la frase talmudica «Chiunque abbia causato la morte anche di una sola anima ebraica, per la Toràh è come se avesse ucciso un mondo intero» – frase derivante da un’interpretazione di Gen 4,10 – un bambino chiede a suo padre: «Papà, come può una persona che ha ucciso un solo uomo essere come una che ha ucciso il mondo intero?». Il padre rispose: «perché uccide anche tutti i bambini e i bambini dei bambini che sarebbero potuti nascere da quella persona» (cfr. C. Potok, Il mio nome è Asher Lev, Garzanti, Milano 1999, p. 18).
[26] Quanta «disinformazione» formativa e quanta distorsione educativa sono state e sono perpetrate, tutte le volte in cui, per esempio, nella catechesi e nell’omiletica cristiano-cattoliche, questo comandamento è stato ed è sostituito dalla formulazione non commettere atti impuri, quasi che atti non esaltanti come, per es., la masturbazione potessero e possano essere più importanti, anzitutto nel rapporto con il Dio della rivelazione sinaitica (e di Gesù Cristo), rispetto all’adulterio!
[27] A. Sacchi, I libri storici, p. 156.
[28] J.A. Soggin, Introduzione all’Antico Testamento, Paideia, Brescia 19874, p. 178.
[29] Il verbo hmd, riferito alla donna, esprime un desiderio intenso di possesso come anche il verbo ’wh proprio degli altri elementi di cui tale brama è proibita in questo v. 21. Il fatto stesso, però, che i vocaboli utilizzati siano diversi dimostra che la specificità del desiderio verso la donna è degna di essere esplicitata.
[30] J.-L. Ska, Ricchezza e povertà nell’esperienza e la legislazione dell’Esodo, p. 345.
[31] A. Nepi, Le maschere e il volto, p. 25.
[32] A. Fanuli, La spiritualità della Tôràh, in Aa.Vv., La spiritualità dell’Antico Testamento, EDB, Bologna 1987, pp. 75-76;
[33] Per quanto l’uso dei comandamenti nella catechesi sia «post-biblico, la collocazione redazionale nella narrazione del Sinai lascia intravedere qualcosa di analogo alla catechesi (vedi 24,12) così come il loro indirizzarsi alle singole persone. Ma mentre l’indirizzo è alle singole persone, il contenuto non è circoscritto al benessere privato. Il punto focale sta nel proteggere lo stato di benessere della comunità, a tal fine il singolo individuo riveste un ruolo tanto rilevante» (T.E. Fretheim, Esodo, p. 288).
[34] D’altronde «il fatto che sia stato trasmesso in due versioni diverse… e che lo stesso divieto dell’idolatria venga continuamente ripetuto, amplificato, aggiornato nel corso della legislazione biblica, evita al lettore di adorare un unico testo come un vitello d’oro. Si tratta di una deliberata polifonia, che interpella il lettore, lo invita ad entrare in dialogo tra più versioni della stessa realtà, a cogliere una Presenza, la quale resta sempre al di là delle sue rappresentazioni, ad ascoltare una Voce che risuona sempre oltre altre voci» (A. Nepi, Le maschere e il volto, p. 26).
[35] L’adesione al contenuto delle dieci parole è un’opzione fatta «con l’intelligenza, con il cuore e nella vita, nei momenti di confessione nel culto e nella ferialità dei gesti quotidiani. Non a caso il decalogo contiene prescrizioni cultuali e comportamenti etici» (A. Fanuli, La spiritualità della Tôràh, p. 76).
[36] A. Sacchi, I libri storici, p. 158.
[37] Cfr. J.-L. Ska, Ricchezza e povertà nell’esperienza e la legislazione dell’Esodo, p. 345. Nel testo ebraico di Es 20,1ss «la prima parola è «Dio» (Es 20,1.2) e le ultime «il tuo prossimo» (v. 17), segnando così i limiti estremi di questo discorso: il Padre dell’umanità propone alcune norme affinché tutti gli uomini si sentano fratelli» (R. Badenas, Legge di libertà, p. 69).
[38] Cfr. F. Ferrario, I dieci comandamenti, Claudiana, Torino 2001, p. 11.